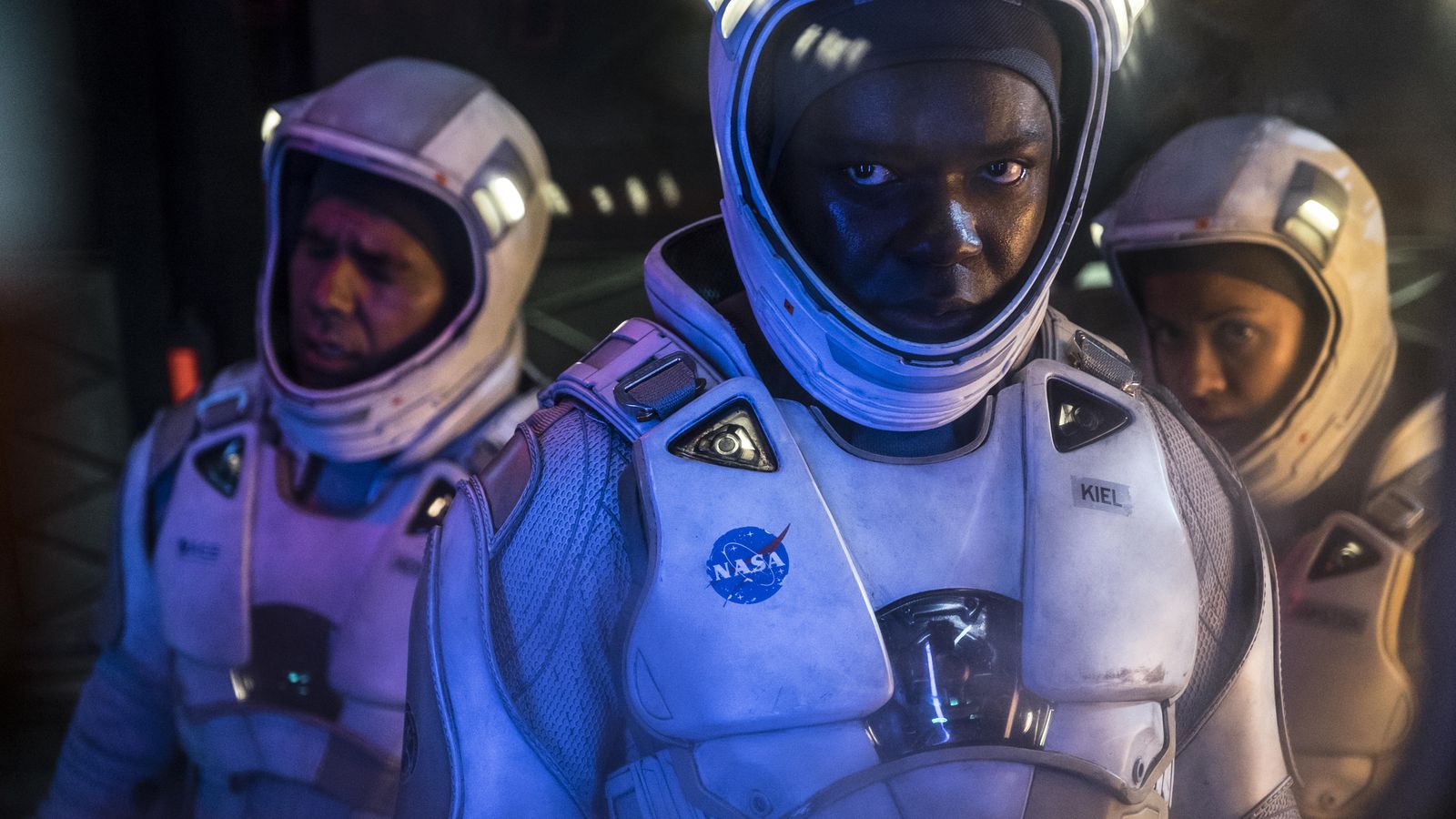Mindhunter: elegante narrazione seriale
Mindhunter è come un serial killer. Convince perché ha delle marcature, degli stressori. A volte dopo la visione di un episodio mi sorprendo a rianalizzare ciò che ho visto, diventando per qualche minuto come i protagonisti Holden Ford e Bill Tench, interpretati rispettivamente da Jonathan Groff e Holt McCallany in modo magistrale. E considerate che quei personaggi hanno dei riferimenti storici viventi: la serie è ispirata al libro Mind Hunter: Inside FBI’s Elite Serial Crime Unit scritto da Mark Olshaker e John E. Douglas, che racconta della nascita ed evoluzione della Unità Crimini Seriali dell’FBI tra anni ’70 e ’80. Da lodare anche la ricostruzione ambientale di quell’epoca, precisa in ogni dettaglio e anche curata nell’evoluzione tecnologica e sociale.
 È questo uno degli altri aspetti che aiuta a rendere Mindhunter una serie che prende fin da subito lo spettatore: l’evoluzione. Da un lato abbiamo la storia dei primi detective che hanno iniziato ad investigare sui serial killer, all’epoca omicidi sequenziali; dall’altro abbiamo l’evoluzione di ogni singolo criminale, più d’uno, seguiti e registrati da Ford e Tench per comprendere come ragiona (o non ragiona) la mente di coloro che non si limitano ad uccidere, ma continuano a farlo vittima dopo vittima. Evolve anche il tipo di killer, il suo carattere, il suo metodo. Anche il metodo dei due detective cambia e si adegua.
È questo uno degli altri aspetti che aiuta a rendere Mindhunter una serie che prende fin da subito lo spettatore: l’evoluzione. Da un lato abbiamo la storia dei primi detective che hanno iniziato ad investigare sui serial killer, all’epoca omicidi sequenziali; dall’altro abbiamo l’evoluzione di ogni singolo criminale, più d’uno, seguiti e registrati da Ford e Tench per comprendere come ragiona (o non ragiona) la mente di coloro che non si limitano ad uccidere, ma continuano a farlo vittima dopo vittima. Evolve anche il tipo di killer, il suo carattere, il suo metodo. Anche il metodo dei due detective cambia e si adegua.
Regia e sceneggiatura lavorano in maniera ottimale per fare in modo che lo spettatore sia a suo agio, anzi, invogliato, sedotto, come una preda di un serial killer. Ci sono momenti di alcuni episodi in cui mi è chiaro che la regia vuole comunicarci non solo la storia, ma anche il senso di essa: l’atmosfera di quei momenti. La salita che si allunga dietro alla macchina dei protagonisti, che vanno in retromarcia: una metafora perfetta per tradurre l’arduo lavoro che Ford e Tench (soprattutto il primo) dovranno fare. La composizione delle camere di motel che visitano per motivi di lavoro i protagonisti, altro esempio di come ci sia una assonanza narrativa tra ciò che viene raccontato e quello che vediamo di fronte a noi. Con la certezza che tutto ciò sia da attribuire al coinvolgimento di David Fincher (regista e produttore esecutivo insieme a Charlize Theron), famoso per altre rappresentazioni di serial killer come Seven (1995) e Zodiac (2007).
Ben presto la vita lavorativa e privata dei protagonisti si uniranno in un flusso coerente, elegante e ben costruito di eventi. La struttura di Mindhunter è poi la prima ad usare come vantaggio, da quanto ne sappia, una caratteristica di Netflix: l’assenza di una determinata lunghezza degli episodi. Questo crea una situazione per cui il serial può permettersi di narrare ogni nocciolo tematico della storia senza dover arrivare a compromessi con la struttura classica televisiva. Invece di mettere in ogni episodio un “criminale della settimana”, poi da scartare una volta acciuffato, Mindhunter si interroga piuttosto su argomenti. Ogni episodio è costruito con estrema cura attorno ad un singolo tema, che rimane nel background, ma permette di passare in modo fluido da episodi di sessanta minuti a episodi da quaranta o trentacinque.
Per unire coerentemente ogni episodio si è dovuto perciò trovare delle marche stilistiche che servono a convincerci che sì, stiamo osservando una storia epica, potente, anche tragica, ma dannatamente affascinante. Joe Penhall e gli sceneggiatori hanno così trovato da un lato dei luoghi ricorrenti, come il già citato motel e le corsie degli aerei che i personaggi devono usare per spostarsi; dall’altro dei momenti ricorrenti che funzionano come “checkpoint” narrativi, come la scena finale di ogni episodio oppure il campo-controcampo di quando Ford, Tench, Carr e l’ultimo arrivato, Smith, ragionano sui cacciatori che inseguono – diventando, per qualche istante, dei cacciatori a loro volta.
 Infine, ma non per minore importanza, c’è il terzo incomodo: la magnifica, spettacolare e in questo caso anche sensuale Anna Torv, già star di Fringe e dello sconosciuto Secret City. La Torv non è solo una scelta azzeccata, perché anch’essa rappresenta un personaggio storicamente esistito, è una scelta perfetta. In Mindhunter l’attrice dimostra di poter far dimenticare il volto che aveva assunto per il telefilm di J. J. Abrams, non solo per l’aspetto che deve assumere nell’interpretare Wendy Carr, ma anche per la gestualità, i movimenti, il modo di agire così calibrato. A volte con microespressioni e movimenti, nel pieno silenzio della scena, ci comunica più di mille parole. Ed effettivamente lei e la ragazza di Ford, Debbie (Hannah Gross), una giovane studentessa tutta hippie e anni Settanta, così come tutti i personaggi femminili sono messi in scena in modo preciso: sono lì per farci capire cosa i serial killer vogliono dalle loro vittime. Forse addirittura cosa vogliono tutti gli uomini dalle donne, dalle madri, dalle ragazze, dalle mogli. Cosa vogliono veramente e quali estremi gesti questa voglia, se repressa e fonte di stress, li porta a compiere.
Infine, ma non per minore importanza, c’è il terzo incomodo: la magnifica, spettacolare e in questo caso anche sensuale Anna Torv, già star di Fringe e dello sconosciuto Secret City. La Torv non è solo una scelta azzeccata, perché anch’essa rappresenta un personaggio storicamente esistito, è una scelta perfetta. In Mindhunter l’attrice dimostra di poter far dimenticare il volto che aveva assunto per il telefilm di J. J. Abrams, non solo per l’aspetto che deve assumere nell’interpretare Wendy Carr, ma anche per la gestualità, i movimenti, il modo di agire così calibrato. A volte con microespressioni e movimenti, nel pieno silenzio della scena, ci comunica più di mille parole. Ed effettivamente lei e la ragazza di Ford, Debbie (Hannah Gross), una giovane studentessa tutta hippie e anni Settanta, così come tutti i personaggi femminili sono messi in scena in modo preciso: sono lì per farci capire cosa i serial killer vogliono dalle loro vittime. Forse addirittura cosa vogliono tutti gli uomini dalle donne, dalle madri, dalle ragazze, dalle mogli. Cosa vogliono veramente e quali estremi gesti questa voglia, se repressa e fonte di stress, li porta a compiere.