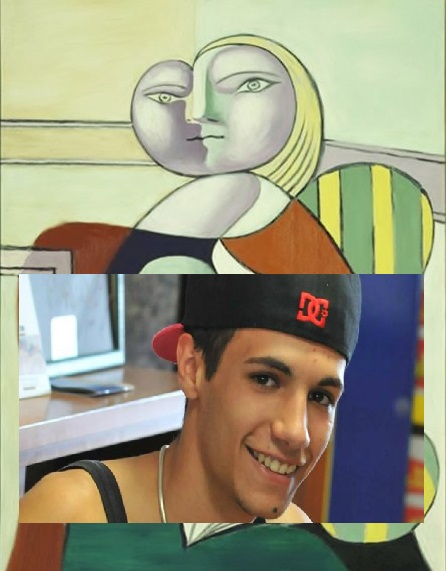Lo faccio per me. La dottoressa Andreoli sul materno e sugli adulti-giovani
Nella splendida cornice dell’Aula Magna, ieri, 27 maggio 2022 si è tenuta la presentazione dell’ultimo libro della dottoressa Stefania Andreoli, “Lo faccio per me. Essere madri senza il mito del sacrificio”. Un incontro a cura del progetto culturale “Il confine tra me e l’altro”, avviato in piena crisi pandemica nel 2020 con l’intento dichiarato di rimettere al centro chi, fino a quel momento, era stato sempre in panchina: gli universitari e la salute mentale – in università, e in senso più ampio ovunque sia necessario spenderci una riflessione e un’azione collettiva -. L’evento è stato moderato e organizzato da Aurora Pallevezzati, Valentina Floris, Irene Sutti, studentesse di medicina e Cinzia Orlando, dottoranda in filosofia.
Sulla poltrona centrale di questa chiacchierata si è seduta, come preannunciato, la Andreoli: psicoterapeuta, psicologa, analista, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano, già autrice di Mamma ho l’ansia (2016), Papà fatti sentire (2018), Mio figlio è normale? (2020). Sulla poltrona, poi, non c’è stata. Forte di una promessa fatta pochi minuti prima, la dottoressa, salda sul tacco impegnativo per i sampietrini pavesi, si è destreggiata nel suo intervento in piedi, decentrata, per non dare le spalle all’emiciclo pieno di partecipanti. L’incontro ha preso il via da una domanda che è forse la più gettonata del mondo contemporaneo che si interfaccia con il neonato/bambino/adolescente/giovane-adulto: qual è la cosa giusta? O meglio: Più giusta? A cui non può sfuggire all’interlocutore attento la contro domanda: più giusta per chi?
UNA ALLA VOLTA, PER CARITÀ
Il femminile vive impregnato di una stereotipia che attraversa trasversalmente tutto quello che una donna può dire di essere: una figlia, una sorella, un’amica, un’amante, una compagna, una professionista, una che gioca a bocce il venerdì sera, che il sabato ha estetista e parrucchiera. Ma anche: una dimentica, una sbadata, una brillante, un’irrecuperabile, una pettegola, una accudente. Non esime da questo elenco la qualifica delle qualifiche: una mamma. Poi una madre. Soprattutto una “buona madre”. Cosa significa essere una buona madre? L’ipotesi del libro dell’Andreoli, suffragata dall’esperienza clinica, dai racconti che le portano i propri pazienti nella stanza delle parole è questa: che fino ad ora, ci hanno fregati. Che la risposta che avremmo dato e che alcuni ancora danno non è sufficiente. Non ha funzionato. Il modello di abnegazione, oscurazione, opacizzazione, traslazione del sé in favore del nuovo che viene al mondo non è vincente, non è funzionale. La buona madre non è il Cristo in croce, non deve immolarsi. Non deve salvare nessuno. Credere che la vita di qualcun altro sia di totale dipendenza da quello che faccio per lui, significa togliergli la grande chance che questi faccia qualcosa per sé. Che si renda padrone delle proprie scelte, che arrivi addirittura a intravedere che può direzionare, può direzionarsi, può immaginarsi felice, esserlo, a dispetto della grande falsa promessa che va sotto il nome del “lo faccio per il tuo bene”.
A corredo di questa credenza che ha abitato tutte le famiglie felici (leggasi: infelici a modo proprio, come ci ricorda Tolstoj) degli ultimi anni, c’è una ragione culturale che va esplicitata come premessa. Se non lo si fosse capito dal dibattito che anima i social e non solo degli ultimi tempi, è bene che si tenga il punto su questo: la donna non è una cosa per volta. Non lo è quando a diciott’anni vuole frequentare l’università e contemporaneamente fare la skater. Non quando si rende confidente di un’amica sotto chemioterapia e il weekend successivo è in solitaria all’estero. Il punto non bisogna perderlo nemmeno quando si parla di madri. Essere madri non è escludente rispetto a quello che si è stati e rispetto a quello che si sarà. Al contrario, il sacrificio che ci hanno voluto raccontare, e che prende le radici dal latino “sacrum”, “sacro” è stato distorto fino a farlo rientrare nel contenitore per cui una volta che il figlio è nato, come fosse un liquido, ha preso tutto lo spazio che c’è e ora la bottiglia è piena. La mamma, al massimo, può fare l’etichetta e indicare i valori energetici, la quantità di calcio, di sodio. Che vuole di più? Non si è così realizzata? Non si è compiuto il più alto dei miracoli? Ha davvero ancora necessità di essere quella che era, di essere qualcos’altro? E se suo figlio/sua figlia non le bastasse il suo sentimento di amore sarebbe davvero profondo, pieno? È il mito dell’amore incondizionato, che, spoiler, non esiste! Citando il libro di cui si sta trattando: “se esistesse l’amore incondizionato […] sarebbe l’amore dei mistici. L’amore divino di chi ama tutti e quindi nessuno. L’amore distaccato che ama perché se ne sta al di sopra, non ne riporta i segni, non viene scompigliato, non vede condizionata la sua vita”.
Dicono di me che sono una strega drogata e truccata e piena di sé, cantava Cremonini. Se eccettuiamo la droga – sulla quale si ammettono riserve – non è poi liberatorio essere streghe, truccate, piene di sé? Nella riabilitazione del significato di egoismo – che la Andreoli opera a circa metà del libro – la collettività non è messa da parte, – come potremmo del resto, ci viviamo immersi! – diventa anzi un luogo in cui sto bene perché porto qualcosa di me, perché porto me. Integro e frantumabile, correndo il rischio che ora che la tribù non serva più per i bisogni base di sopravvivenza, possa diventare altro: un luogo in cui stare prima, in cui fiorire poi.

IL RISCHIO DEL FALSO SÉ E GLI ADULTI-GIOVANI
Winnicott, pediatra e psicoanalista britannico, idea il concetto di vero Sé e falso Sé. Il vero Sé sarebbe il “gesto spontaneo”, l’idea personale, il sentirsi reale e creativo. Il falso Sé, invece, non farebbe “altro che raccogliere insieme gli elementi dell’esperienza del vivere”. La madre che non ha colto e valorizzato il gesto del figlio ma ha sostituito “il proprio gesto chiedendo al figlio di dare ad esso un senso tramite la propria condiscenda fa sì che si sviluppi lo stadio più precoce del falso Sé, che dipende dall’incapacità della madre di capire i bisogni del figlio”
Mediante il falso Sé il bambino si crea un sistema di rapporti falsi che sembrano reali, egli “diventa proprio come la madre, la balia, la zia, il fratello e qualsiasi persona che in quel momento domini la scena”. L’esistenza del vero Sé è nascosta e la realtà diviene non tollerabile.
L’embrione di questo rischio che paventa Winnicott, se ha messo radici nel bambino, può ramificarsi e consolidarsi nel giovane-adulto. La Andreoli, riportando i dati clinici, esprime una preferenza terminologica non di poco conto: gli adulti- giovani, ricomprendendo una fascia d’età che riempie gli studi psicoterapeutici e che strizza l’occhio agli – anta. Il focus della chiacchierata si allarga per abbracciare quello che sarà il tema del suo prossimo libro: noi. Le nostre difficoltà, il nostro smarrimento, il “va bene se funzioni”, la sua giovane paziente che piange quando le dicono che è brava a fare la cameriera, perché nessuno glielo ha mai detto per qualcosa che la riguardasse e che avesse imparato a fare da sola, in autonomia. La validazione di sé per quello che si fa, e quindi il bene da meritarsi e che non conta per il fatto che esisti, che sei, e che sei come sei.
Se i ventenni/trentenni non sono appetibili come soggetti politici, come elettori, come potenziali acquirenti, se non sanno chi sono e non sanno cosa vogliono, se è così che vengono narrati e dall’immagine di Padoa-Schioppa di “bamboccioni” del lontano 2007 ci si è allontanati di poco, è ancora possibile che scommettano su di sé? Che facciano per sé?
La Andreoli ha fatto la sua giocata: e risponde di sì. È possibile a patto di riconoscersi tra autentici, di modularsi sul ritmo dell’autosoddisfazione, sostenibile e replicabile. Del non chiedere che l’altro ti renda felice, ci ricorda la dottoressa, che sarebbe, questo, un comportamento violento. Diventa ciò che sei, da Pindaro in poi, è non solo vero. Ma oggi, più che mai, necessario: per vedersi compiere, abbeverarci, schiudersi, senza il timore che non sia la nostra stagione.