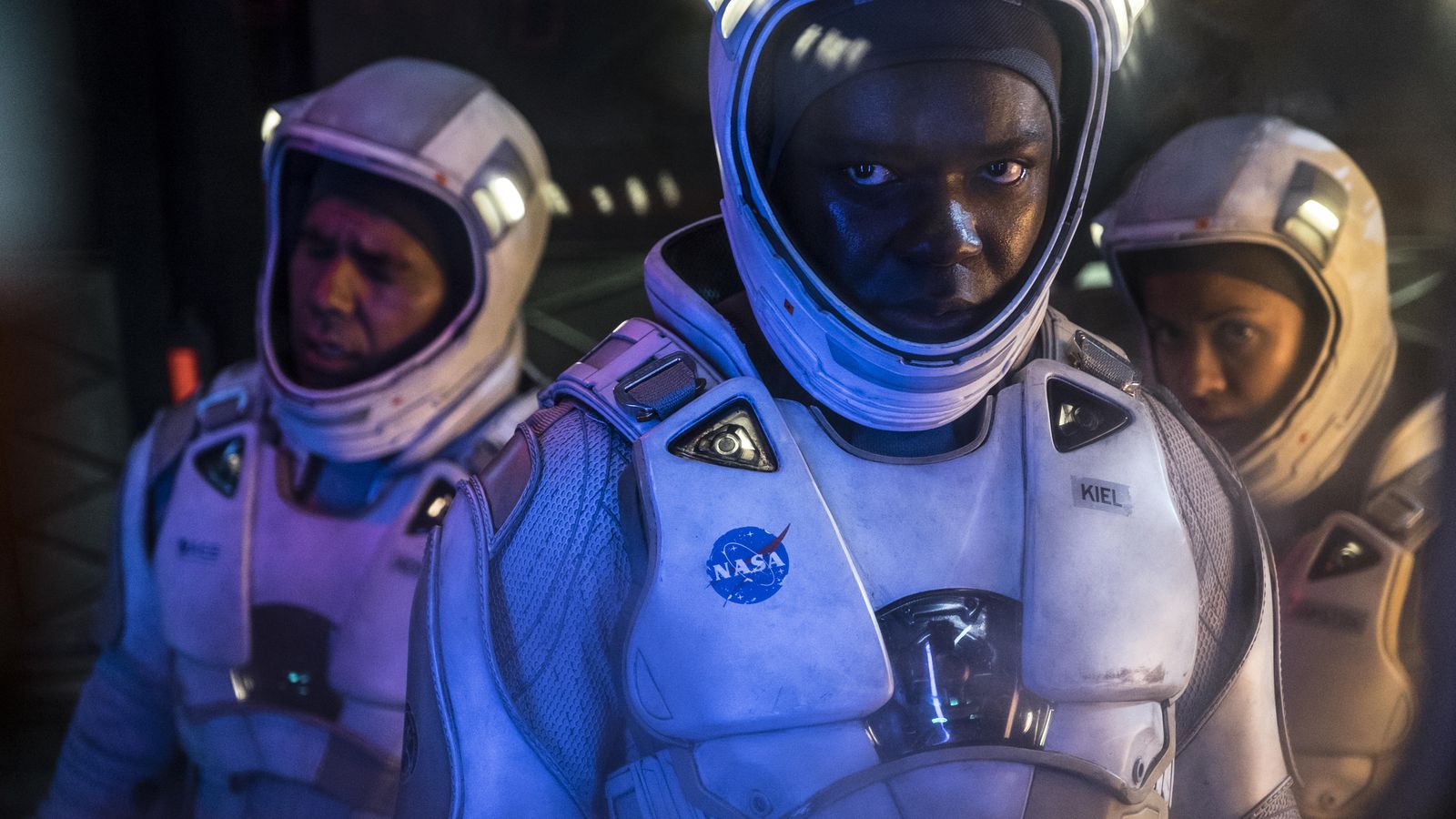“The young Pope”: tra dominio dispotico e disarmante umanità
Su Sky Atlantic va in onda per la prima volta il 21 ottobre dell’anno corrente The young Pope, serie tv diretta e ideata da Paolo Sorrentino, in coproduzione internazionale.
Fermandoci al titolo sembrerebbe di star approcciando l’originale e intrigante vicenda di un papa “diverso dall’ordinario”, con peculiari caratteristiche da giovane uomo di mondo, dal fascino brioso del classico bello e impossibile, che si trova a capo dello Stato Vaticano come per ironia della sorte, e che terrà sicuramente in serbo un atteggiamento che ci sembrerà in ironico contrasto con l’ambiente rigidamente cattolico in cui il belloccio si trova per caso.
All’inizio della prima puntata il corpo nudo e aitante di Jude Law e quello che lo spettatore pensa sia il suo primo discorso papale in pubblico (un inno all’amore verso il futile, all’apertura verso la scienza, all’estinzione di qualunque tabù e bigotto pregiudizio) aprono non solo all’illusione di aver pensato bene, ma anche allo stupore di riscontrare una “giovinezza” che avrà sicuramente sulla Chiesa un impatto molto più profondo del previsto.
Ma queste prime parole di Papa Pio XIII, novello padre della Chiesa, sono solo l’oggetto di un sogno. Il discorso effettivo, mostratoci dopo qualche puntata, sarà invece costruito, in totale simmetria, come una netta e globale opposizione all’iniziale inno all’amore dell’altro come tramite per il raggiungimento di Dio; all’esaltazione della fragilità umana e dell’importanza della dimensione dell’edonistico si sostituisce il discorso forte di un papa aggressivo, dal volto oscurato, che inneggia all’annullamento della dimensione umana e alla totale dedizione per quella divina in una passione ossessiva. Passione che diventa dispotismo, tendenza all’identificazione totale dell’io con il divino, malata smania di dominio.
L’evidente contrasto tra i due discorsi, che si riversa anche nella dimensione estetica della costruzione delle scene, diventa la filigrana concettuale di tutta la serie. Si scopre presto infatti che l’annullamento dell’empatia nei confronti dell’altro e il dispotismo religioso sono l’unica forma di devozione possibile per un individuo a cui la dimensione del fragile amore umano è stata negata all’età di 8 anni, al momento dell’abbandono da parte dei genitori presso un convento. Ma il dispotismo malato di cui Pio XIII si fa portatore in ogni suo anche più impercettibile modo di parlare, vestire, mangiare, relazionarsi con l’altro, fa, durante l’evoluzione della storia, costantemente i conti con dei forti momenti di tensione in cui il bisogno di attraversare la dimensione umana e affettiva quasi diventa spasmodico: a più riprese il pontefice sogna l’abbandono dei genitori, ricorda i tratti della madre, palesa l’ardente desiderio di incontrare i due, guarda nella direzione di Venezia, dove pensa che abbiano passato la loro vita. All’atteggiamento forte e dominante, poi, si affianca a tratti anche la profonda dedizione nei confronti di Ester, moglie infelice di una guardia svizzera, quasi l’unica donna che riesce a scorgere e amare profondamente le linee di umanità del giovane papa.
Queste componenti e le ripetute e sempre crescenti crisi del papa in relazione al suo operato e al suo rapporto con la fede rappresentano il suo graduale cammino verso la scoperta dell’umano, in un processo di evoluzione personale quasi impercettibile e ciononostante molto forte, che si anima della valorizzazione sempre crescente dell’amore, e che trova il suo momento di apice nel discorso tenuto a Venezia, ove celebra la valenza divina del sorriso.
Ma il rapporto di opposizione tra la concezione dispotica e quella fraterna di amore non si limita alla semplice caratterizzazione di un personaggio e del suo cammino di evoluzione.
Sorrentino ci presenta un papa giovane che paradossalmente diventa un papa “vecchio”, dispensatore di dispotismo e causa di terrore, chiusura cieca a valori obsoleti, esasperazione di tutti i divieti che la Chiesa ha predicato in anni anche bui. Vuole forse in tal modo lasciare spazio ad uno spiraglio di cinismo nei confronti del concetto di “mediazione”, su cui si basa nel XXI secolo un’istituzione di tal portata? Se è vero che la Chiesa afferma ancora, se pure in variate modalità, concezioni in larga misura obsolete, quali la negazione dei diritti civili, la negazione dell’aborto, la negazione del diritto all’eutanasia, quanto motivo di esistere può avere il concetto stesso di “mediazione” tra l’istituzione stessa ed una realtà in evoluzione sociologica continua, la cui meta è evidentemente la negazione di ogni tabù? Il bigottismo esasperato è forse un modo di risolvere il problema di un bigottismo moderato ma fallace? Sorrentino presenta la radicale opposizione come fonte di affermazione, in contrasto con una moderazione insufficiente. Il sogno del papa e il contenuto effettivo del suo discorso hanno una sola cosa in comune: l’assenza di moderazione. Entrambi gli atteggiamenti sono spiazzanti e apparentemente inadeguati, ma paradossalmente una delle due varianti è forse per Sorrentino l’unico modo per perpetrare l’esistenza di un’istituzione forse anacronistica.
Ma la genialità di Sorrentino sta nella maniera magistrale in cui riversa il concetto che sta alla base della storia (questa continua tensione tra la drammatica fragilità umana e la tendenza ad una certa divina “capacità di dominio”) anche nella vicenda e nell’evoluzione di tutti gli altri personaggi, schiavi di vizi che tendono a reprimere morbosamente o ad assecondare ambiguamente, persi nella consapevolezza drammatica del limite che attanaglia l’uomo di fede, piegati nell’inerte preghiera di chi pensa a fare “quel che si può”, a mandare avanti, come si manda avanti un vecchio mulino, un’istituzione di “rassegnati”, un’istituzione utilitaristica e terrena, che come tutte le realtà di tal genere, rischia il tracollo, pur nella splendida circolarità simmetrica e straniante del palazzo Vaticano, che diventa quasi una dimensione a sé stante, ove il silenzio in cui si muovono queste anime perdute – quasi alienate in sé – conserva la pregnante tensione di un comune destino.