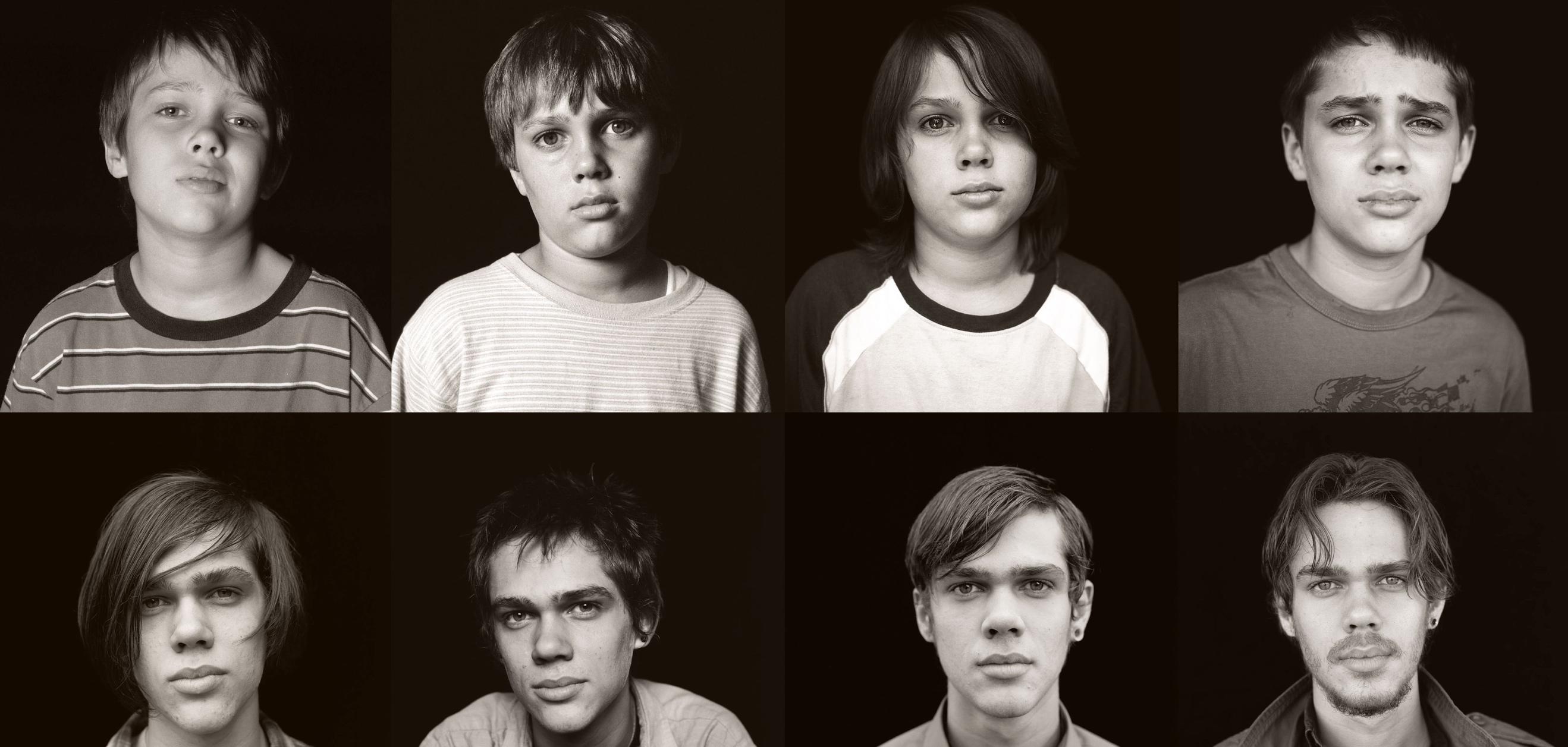Umano, troppo umano: “Don’t worry”
Gus Van Sant ha deciso, per la seconda volta nella sua ormai trentennale carriera, di misurarsi con un film biografico. Lo fa dieci anni dopo Milk (2008), raccontando una storia più intima e decisamente meno nota al pubblico europeo. Quella che si conferma essere una costante del suo Cinema è invece l’altissima attenzione riservata al mondo interiore del suo protagonista, il vignettista tetraplegico John Callahan. Non lasciatevi ingannare da trame e trailer: non ci troviamo di fronte alla vicenda tipo di un qualunque inspirational-movie, genere che pure Van Sant ha toccato con Good Will Hunting (1997). Don’t worry (2018) è la celebrazione della mediocrità, la dimostrazione che, di dispregiativo, quel termine ha davvero poco.
John, orfano, alcolista e disabile, non possiede capacità fuori dal comune, non viene presentato come un eroe, non raggiunge chissà quale riscatto sociale. Il suo approdo è l’accettazione della sua condizione sfavorevole, la consapevolezza delle proprie dipendenze e debolezze, e più di tutto la convivenza con i suoi fantasmi. Il mosaico della sua vita si compone progressivamente nel corso del film; sin da subito, è la leggera sgranatura dell’immagine a farci capire che la vicenda si svolge tra gli anni settanta e ottanta, mentre la regia è sempre estremamente sobria, salvo qualche soluzione più estrosa a livello di montaggio. Il regista statunitense trova l’incarnazione perfetta del suo personaggio principale in Joaquin Phoenix, ventitré anni dopo la loro collaborazione in To die for (1995). Il delicato e problematico rapporto di John col suo corpo è reso credibile da Phoenix a livello fisico ma soprattutto a livello emotivo. È bene tuttavia ricordare che il tema della disabilità, e dei connessi problemi della vita quotidiana, è stato affrontato con ironia già in diversi film, non ultimo l’ottimo (e quasi ignorato) The sessions (Ben Lewin; 2012). Il grande merito di Van Sant, che figura anche come sceneggiatore, è piuttosto quello di saper preservare con cura il mistero del dolore di John; in esso si sovrappongono il rancore verso una madre che l’ha abbandonato, l’ossessione per l’alcol, lo sconforto per la perdita di autonomia conseguente al suo grave incidente. La sua inclinazione al patetico e all’autocommiserazione è stemperata da una vena autoironica corrosiva, che costituirà il fulcro delle sue vignette e lo porterà ad avere un discreto successo. Anche quando il film si affaccia su temi esistenziali e spirituali (veicolati, per così dire, da un meraviglioso Jonah Hill in versione guru), il tanto atteso momento di catarsi non si manifesta del tutto, rivelandosi piuttosto un unico, lungo processo, coincidente con il film stesso.
Il mosaico della sua vita si compone progressivamente nel corso del film; sin da subito, è la leggera sgranatura dell’immagine a farci capire che la vicenda si svolge tra gli anni settanta e ottanta, mentre la regia è sempre estremamente sobria, salvo qualche soluzione più estrosa a livello di montaggio. Il regista statunitense trova l’incarnazione perfetta del suo personaggio principale in Joaquin Phoenix, ventitré anni dopo la loro collaborazione in To die for (1995). Il delicato e problematico rapporto di John col suo corpo è reso credibile da Phoenix a livello fisico ma soprattutto a livello emotivo. È bene tuttavia ricordare che il tema della disabilità, e dei connessi problemi della vita quotidiana, è stato affrontato con ironia già in diversi film, non ultimo l’ottimo (e quasi ignorato) The sessions (Ben Lewin; 2012). Il grande merito di Van Sant, che figura anche come sceneggiatore, è piuttosto quello di saper preservare con cura il mistero del dolore di John; in esso si sovrappongono il rancore verso una madre che l’ha abbandonato, l’ossessione per l’alcol, lo sconforto per la perdita di autonomia conseguente al suo grave incidente. La sua inclinazione al patetico e all’autocommiserazione è stemperata da una vena autoironica corrosiva, che costituirà il fulcro delle sue vignette e lo porterà ad avere un discreto successo. Anche quando il film si affaccia su temi esistenziali e spirituali (veicolati, per così dire, da un meraviglioso Jonah Hill in versione guru), il tanto atteso momento di catarsi non si manifesta del tutto, rivelandosi piuttosto un unico, lungo processo, coincidente con il film stesso.
A fine visione non si rimane appesantiti dal senso di tragedia dei precedenti Restless (2011) e The Sea of Trees (2015), né dal nichilismo di Elephant (2003) e Last days (2005); anzi, noi stessi possiamo fare nostra la ricerca di senso del protagonista, inquieta ma non disperata. L’inno alla mediocrità, intesa finalmente in modo positivo come accettazione della propria piccolezza e transitorietà in un universo turbolento, appare riuscito: sta allo spettatore decidere se sentirsi appagato da questo quadro sincero e semplice; in una parola, “Umano”, oppure deluso da uno scandaglio emotivo troppo umano, ossia né peculiare né sconvolgente.