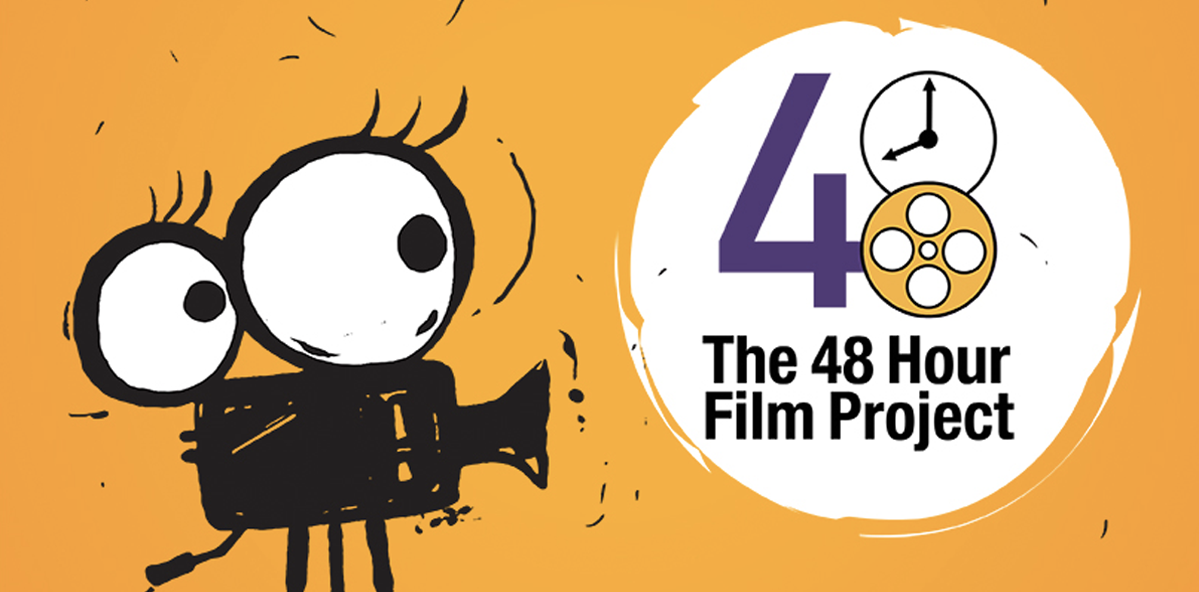Sentire il nulla: “You were never really here”
Nel corso della storia il revenge movie, genere contraddistinto da intrecci narrativi spesso semplici o per lo meno lineari in linea di principio, ha sempre esercitato un grande fascino sul pubblico. Il compiersi della parabola di redenzione, la rivincita della vittima sui suoi aguzzini, per mano sua o di un altro giustiziere, provoca una sensazione catartica in chi la guarda: in parole povere, la soddisfazione di aver assistito a un riequilibrarsi della bilancia della giustizia, seppur in maniera estremamente violenta. L’ultima pellicola della regista inglese Lynne Ramsay, You were never really here (2017), va a collocarsi nel genere, pur andando a tradire tutte le classiche attese dello spettatore. Protagonista indiscusso del film è il sicario Joe, che compare praticamente in ogni singola sequenza: una figura antieroica dai tratti ambigui e, talvolta, repulsivi. Joe, interpretato da Joaquin Phoenix, ha un aspetto trasandato: barba incolta, capelli lunghi e mal raccolti, felpe vissute, un triste cappellino con visiera. Vive ancora con la madre, e spesso subisce gli effetti di visioni traumatiche del suo passato, che lo portano ad avere un principio di tendenze maniacali e suicide. L’emarginazione, la scarsa loquacità e l’efferatezza con cui porta a termine il suo lavoro sono gli unici, classici paradigmi antieroici che egli incarna.
 Non c’è, nello sguardo a metà tra il vacuo e il folle di Phoenix, la purezza del Ryan Gosling di Drive (Nicolas-Winding Refn, 2011), un film a mio parere perfetto per istituire un confronto ambivalente. Da un lato, Ramsay sembra infatti attingere da quell’immaginario noir moderno, fatto di neon taglienti, tenebrosi scorci urbani e di pulsanti musiche elettroniche, sfiorando l’aperta citazione quando scopriamo che l’arma prediletta da Joe è proprio il martello, caro anche al protagonista del film di Refn. D’altro canto, è lampante la volontà della regista di smorzare qualsiasi slancio epico-eroico: tutto è ridotto all’osso, e larghissima rilevanza è concessa al non-visto e al non-detto. Le esplosioni di violenza sono aggirate, suggerite, o mostrate solo parzialmente, in un crescendo di tensione che non trova alcun modo di essere scaricata. Tuttavia, nulla di ciò che accade sullo schermo ha a che fare con il consolatorio o l’empatico, neanche i momenti che si potrebbero definire più intimistici. Dietro a questo enorme lavoro di sottrazione incarnato da Phoenix non c’è che il vuoto stesso, un vuoto che spaventa per la sua insensatezza.
Non c’è, nello sguardo a metà tra il vacuo e il folle di Phoenix, la purezza del Ryan Gosling di Drive (Nicolas-Winding Refn, 2011), un film a mio parere perfetto per istituire un confronto ambivalente. Da un lato, Ramsay sembra infatti attingere da quell’immaginario noir moderno, fatto di neon taglienti, tenebrosi scorci urbani e di pulsanti musiche elettroniche, sfiorando l’aperta citazione quando scopriamo che l’arma prediletta da Joe è proprio il martello, caro anche al protagonista del film di Refn. D’altro canto, è lampante la volontà della regista di smorzare qualsiasi slancio epico-eroico: tutto è ridotto all’osso, e larghissima rilevanza è concessa al non-visto e al non-detto. Le esplosioni di violenza sono aggirate, suggerite, o mostrate solo parzialmente, in un crescendo di tensione che non trova alcun modo di essere scaricata. Tuttavia, nulla di ciò che accade sullo schermo ha a che fare con il consolatorio o l’empatico, neanche i momenti che si potrebbero definire più intimistici. Dietro a questo enorme lavoro di sottrazione incarnato da Phoenix non c’è che il vuoto stesso, un vuoto che spaventa per la sua insensatezza.
Un film che sceglie, a mio parere consciamente, di non farsi amare in alcun modo, in virtù di un nichilismo onnipresente, è un film coraggioso. Coraggio che rimane sicuramente discutibile, di fronte a diverse idee di cinema: sta di fatto che la regista ha rinunciato al sicuro appiglio di personaggi empatici e accattivanti, della loro redenzione, portando avanti un ermetismo spesso e volentieri ostile alla sensibilità del grande pubblico.
Personalmente, mi sento di collocare Ramsay nel ramo dell’autorialità, sia alla luce del suo precedente lavoro, We need to talk about Kevin (2011), sia perché misurarsi con il nichilismo e la mancanza di senso a partire da un genere come l’action è qualcosa che mi ha spiazzato. Abbattendo progressivamente le mie aspettative, questo film ha raggiunto uno degli obiettivi imprescindibili per la mia personale idea di Cinema: quello di sorprendere.