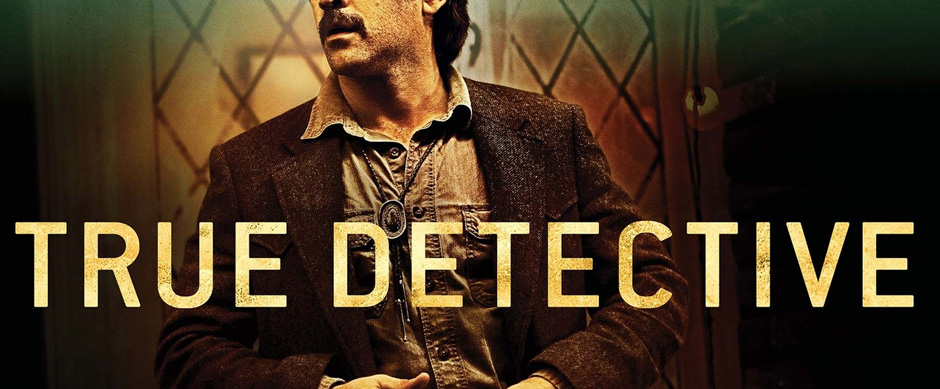True detective: c’è solo una storia, la più antica…
Tradurre, addomesticare, definire. Il grande interrogativo di Nic Pizzolatto si avvale del bisogno, direi ossessivo ma sarei precoce e ingiusto, del giusto medium, lo stesso che possa permettere alla storia di rimettersi in piedi e raccontarsi, sistemare gli angoli della camicia e il nodo alla cravatta: che i bottoni siano quelli giusti e il nodo né poco né troppo stretto.
Lo scrittore americano testa la sua prosa dapprima nel genere racconto, con Ghost-Birds e Between Here and the Yellow Sea (Tra qui e il Mar Giallo, MacAdam/Cage. Maggio, 2006) e nel 2010 esordisce il suo primo romanzo, Galveston, del quale l’edizione italiana è curata nello stesso anno dalla Mondadori (forse un po’ frettolosamente, poiché ho trovato leggendolo che la traduzione fosse macchinosa, quasi superficiale, come di un progetto a scadenza breve, senza possibilità di revisione: la mia, forse, si scopre una speranza, che sia più decisa la cura formale del suo originale americano!). Il romanzo è quasi completamente sintomo e sfogo di una intraprendenza temporale. Sono due le riconoscibili traiettorie, la più recente delle quali è interamente vissuta in un ambiente circoscritto, l’abitazione spoglia, le pareti bianche ridotte all’essenziale, il mare come rumore di fondo, oramai impercettibile. La traiettoria passata, al contrario, si configura dinamicamente: un viaggio in automobile, sui gomitoli sciolti delle strade americane, che sono difatti un tracciato oggetto del ricordo continuo del personaggio, che vive nel presente del romanzo, e che accenna al suo passato soltanto nel desiderio di dissacrarne il peso: una preghiera di oblio.
Una caduta, un dimenticare che permetta, infine, la palingenesi del personaggio (inservibile, sicuramente, il perché non mi è dato rivelarlo, per timore di servirvi uno spoiler, ma c’è un annuncio, senza via di scampo, a inizio romanzo).
(Se) mi è permesso postulare: la lettura di Galveston (ai più permessa solo dopo la visione almeno della prima stagione di True Detective, per la popolarità pressocché acquisita soltanto dopo la trasmissione della serie nel canale americano HBO) è un déjà vu innegabile. Lessi che i galeotti fuori di prigione non sarebbero più riusciti a comprare una libreria, pure solo un mobile adeguato: si accatastano, i libri, a terra, negli angoli, pile che sembrano grattaceli. È ciò che fa prima Roy Cady, il protagonista del romanzo, e poi Rust Cohle (interpretato da Matthew McConaughey) nella prima stagione della serie tv. È una prigione sempre evocata in True Detective, come condizione penale endemica del genere poliziesco, thriller, forse noir, un genere di strade incrociate, richiamata dalla stessa messa in scena che si appropria della selettività genetica della messa in quadro (come scelta del breve frammento di realtà che sta dentro e di tutto il mondo infinito che rimane fuori: «Le persone qui attorno è come se neanche sapessero che esiste un mondo là fuori, potrebbero vivere anche sulla cazzo di Luna!» Ringhia Rust al suo compagno Marty Hart, nel primo episodio, interpretato da Woody Harrelson) e la narrazione si avvale dell’onirico e della memoria come dimensione prevalente, come a giustificare la propria inguaribile incompiutezza, che appartiene anche alla diegetica indagine, risolta solo alla conclusione e al calare del sipario. Un incompiuto che si presenta nella serie già dal paesaggio della Louisiana, dalle suggestioni di Cormac McCarthy (Soprattutto in Suttree, 1979, ma anche in Non è un paese per vecchi, 2005) non di certo estraneo a trasposizioni cinematografiche.
È riconoscere che l’“eternità che ci osserva dall’alto” è tutt’altro che intellegibile. Il percorso di Pizzolatto vuole, prova a risolversi. Addirittura la prima stagione può a rigore essere inscritta in un meccanismo narrativo con happy ending (è Rust ancora, con voce d’eremita, a scrutare il cielo ed ammettere, che dopo tutto “la luce sta vincendo”) ma quello che dalla prima puntata della seconda serie si intravede è semplicemente il caos, l’oscurità, il cui esito riecheggia in ogni episodio. Alla serrata e monolitica ricerca del serial killer si sostituisce una fitta trama di affari finanziari, di appalti, fra politici e poliziotti corrotti, e al vertice di tutto il sindaco della città, legato con strette di mano all’imprenditore Francis “Frank” Samyon (interpretato da Vince Vaughan). La semplicità della Lousiana si piega alla entropica rete di quartieri di Vinci, nella contea di Los Angeles. Gli episodi si susseguono con affanno, lo spettatore fatica a seguire le fila delle indagini dei diversi protagonisti, a primo sguardo una vetrina di attori messi in mostra (Raymond “Ray” Velcoro, interpretato da Collin Farrel, Antigone “Ani” Bezzerides, la bellissima Rachel McAdams, e Paul Woodrugh, cui presta il volto l’attore Taylor Kitsch) e gettati in pasto agli ascolti. L’ambiente e l’atmosfera sono spesso irriconoscibili perché è stabilito che debbano mutare, senza lasciare spiragli di riferimento (nella prima stagione, infatti, il regista era unico – Cary Fukunaga – mentre la seconda ha visto avvicendarsi Justin Linn, Janus Metz, Jeremy Podeswa, John W. Crowley, Miguel Sapochnik, Daniel Attias) e di fondo una voce, Lera Lynn, che nel bar preferito da Velcoro dipinge una melodia tagliente che fungerà da soundtrack, ed un gioco di luci contrastate che respira d’ebbrezza.
Senza scampo. Prima di ogni episodio Leonard Cohen prova a dissuaderci, sussurra the war is lost, sovrastando dei bassi penetranti. È la cronaca di una morte annunciata. Il testo di Pizzolatto non può lasciar intravedere vie di fuga. È claustrofobico, il marciume delle strade, si sente sulla pelle, è un odore nauseabondo. Nel gioco d’autocitazione, questa volta un rimando per coppie oppositive: speranza e morte. Ma non posso, non voglio dire di più. Cercherei soltanto di ricucire risposte che non esistono, su indizi che mai hanno avuto un legame, e ci perderei la testa.