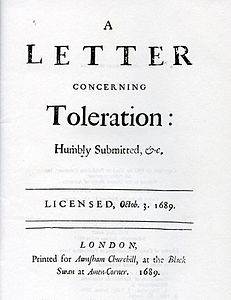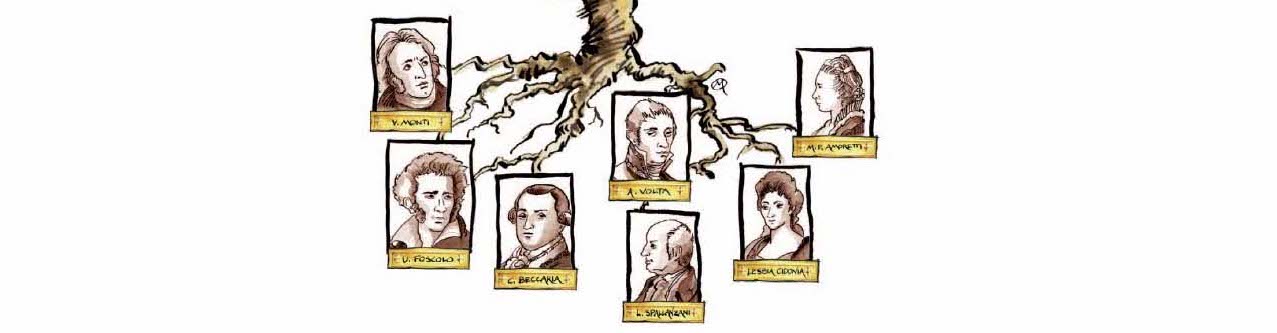Quella saggia tolleranza di John Locke.
C’è questa straordinaria cosa della filosofia, c’è questa thaumazein, meraviglia, che è la capacità di non smettere mai di parlare. Decenni di progresso, secoli di storia trascorsa, ma siamo ancora qui tra dialoghi platonici, metodi scientifici, paura della morte, perplessità sulla natura divina, umanità che annaspa. Che alla fine, forse, altro non è che il più intimo onere di questo amore per il sapere e, come direbbe Edmund Husserl, “Non possiamo rinunciare alla fede nella possibilità della filosofia come compito, nella possibilità di una conoscenza universale.”
E allora eccoci qui, nel susseguirsi di attentati terroristici, continui attacchi all’Europa, a parlare di tolleranza. A leggere una Lettera sulla tolleranza. Repetita iuvant.
Ci troviamo alla fine del XVI secolo. John Locke è rifugiato in Olanda, l’Europa è attraversata da guerre di religione: tanto più si moltiplicano e si affermano le confessioni protestanti, tanto più il problema dell’intolleranza dilaga.
Viviamo nel pieno XXI secolo, l’Europa e l’Occidente sono emblema della secolarizzazione. Eppure alle nostre porte le guerre di religione continuano; eppure il problema della tolleranza non è così lontano dai nostri confini geografici e culturali.
I nuovi, costanti e crescenti flussi migratori, hanno imposto a un’Europa perlopiù cristiana il confronto con altre confessioni religiose: ma se l’Europa si dice tradizionalmente cristiana, risulta nei fatti sempre meno praticante (Stratfor stima che solo il 15% della popolazione europea si rechi regolarmente alla messa domenicale) distaccando sensibilmente i modi di vivere dai dettami religiosi. Eppure, l’affermarsi di confessioni religiose differenti all’interno dei confini comunitari ha fatto risorgere uno spirito religioso che deriva più dal nazionalismo che dalla fede. Improvvisamente ci sentiamo in dovere di difendere il nostro tradizionalismo dagli “infedeli”: sul web si trovano derisioni nei confronti delle tradizioni islamiche, molti partiti politici incentrano il loro programma elettorale sulla difesa dei principi cattolici (e cristiani in generale), il dibattito sulla costruzione delle moschee attraversa l’Europa ormai da anni. Stiamo assistendo a un progressivo intreccio tra interessi politici e religiosi che, con il sentimento di fede, hanno ben poco a che spartire. Ma fino a che punto l’autorità politica può essere tale in tema di religione? “Il diritto di governare o la perizia nell’arte del governo non porta con sé una conoscenza certa della religione”.

E’ questa la risposta che Locke fornisce a un dibattito tanto antico quanto lo è il problema della tolleranza. Allo Stato, al governo, spettano la tutela della salvezza terrena; alla Chiesa, agli ecclesiastici, la tutela della salvezza eterna. Il magistrato, ci dice il filosofo inglese, è in diritto di intervenire in ambito religioso solo se una determinata confessione rappresenta una minaccia alla sicurezza e all’equilibrio dello Stato stesso. Saranno in molti a pensare che è questo il caso, che i continui attentati al cuore dell’Europa non sono che una riprova della minaccia che l’Islam rappresenta per l’Occidente: è quindi corretta una continua intromissione della politica in ambito religioso, per arginare il più possibile la confessione islamica in territorio europeo.
Intolleranza.
Di qui il perpetuo dibattito sulla costruzione di moschee, che nel caso italiano, è divenuto una vera e propria interdizione alla loro realizzazione. Luoghi di proselitismo, di radicamento, di progettazione di attentati terroristici. Ma il nostro Locke non ha taciuto su tale aspetto.
“(le riunioni) esse di solito hanno fama di essere fermenti delle sedizioni e luogo di formazione delle fazioni; e forse qualche volta lo sono anche state, ma non per qualche loro carattere particolare, bensì per una sfortunata conseguenza di una libertà oppressa o mal costituita. Queste accuse cesserebbero se si concedesse la tolleranza a coloro ai quali spetta, con una legge che obbligasse tutte le Chiese a insegnare e porre ciò come fondamento della loro libertà.” Parole che non potrebbero apparire più attuali. Più volte abbiamo sentito gli Imam sostenere che luoghi di culto ufficiali aiuterebbero ad arginare radicalizzazioni e fenomeni terroristici: la costruzione di moschee permetterebbe a ciascun membro della comunità di essere costantemente controllato dagli altri.
Ma non solo.
Il riconoscere luoghi di culto ufficiali ad altre confessioni religiose risponde ai principi di laicità e tolleranza di cui l’Occidente si fa emblema. Ciò permetterebbe una reale integrazione degli immigrati nella nostra società, arginando il più possibile fenomeni di emarginazione sociale. Ce lo dice lo stesso Locke di quanto una libertà oppressa o mal costituita possa essere dannosa. Del resto lo abbiamo imparato a nostre spese: gli attentatori del Bataclan (cafè concerto parigino colpito dallo Stato Isalmico il 13 novembre 2015) erano tutti immigrati di seconda generazione che vivevano una condizione di forte disagio sociale e stigmatizzazione, emarginati nelle periferiche banlieu parigine. Scenari di discriminazione sociale, emarginazione, sopportazione e non tolleranza non possono che dare adito a sentimenti di frustrazione, rabbia, inimicizia. Lo Stato Isalmico dell’Iraq e del Levante non ha altro interesse che lo strumentalizzare l’odio nei confronti della cultura e dello stile di vita occidentale, a cui molti immigrati di religione islamica si sono progressivamente avvicinati, secolarizzando il sentimento religioso. E l’incapacità europea di essere davvero tollerante e laica, non fa che preparare il terreno a divergenze culturali e alle stragi, cui continuamente assistiamo.
Se lo Stato, dunque, ha un ruolo nella religione, è proprio quello di garantire la libertà di culto e la tutela delle diverse confessioni.

La Lettera sulla tolleranza, racchiude quindi in sé quell’intimo compito della filosofia che è il guidare sempre l’uomo attraverso il pensiero, presentandosi come un testo cardine tanto nel XXVII secolo quanto oggi.