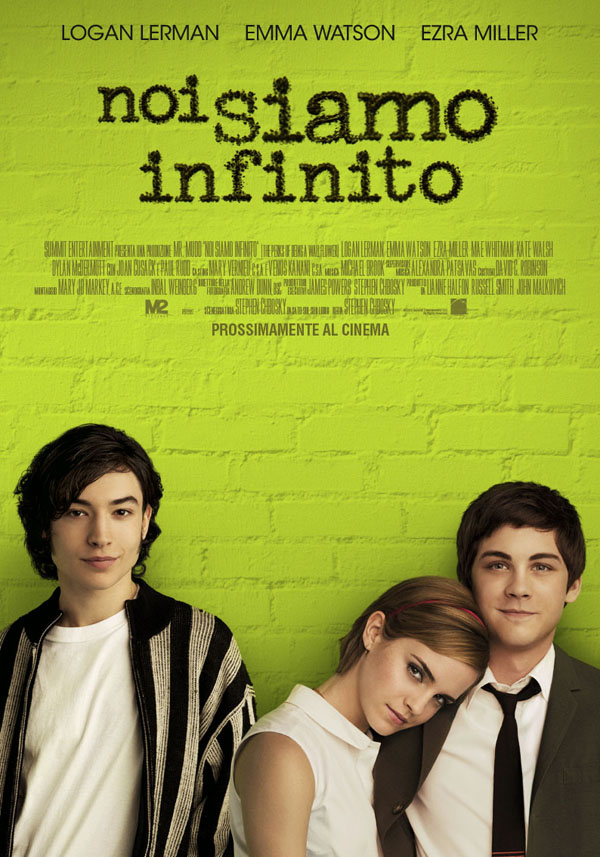L’aratro – simbolo poetico d’abbandono e solitudine
Eurialo cade riverso nella morte, il sangue scorre / per le belle membra, e il capo si adagia reclino sulla spalla: / come quando il fiore purpureo reciso dall’aratro / languisce morendo o come i papaveri che chinano il capo / sul collo stanco, quando la pioggia li opprime.
L’immagine dell’aratro, sin dalle origini della letteratura, è stata spesso associata al dolore e alla sofferenza, non solo a quella fisica del lavoro e della fatica in sé, ma anche e soprattutto a quella delle amarezze e afflizioni dell’anima.
Fonti preziose a tal proposito sono Esiodo, il libro V del De rerum natura lucreziano, il libro I delle Georgiche di Virgilio, l’incipit del De raptu Proserpinae di Claudiano e la Medea senecana. Queste unanimi tramandano il tòpos per cui l’invenzione e l’utilizzo del vomere per le zolle di terra, e della corrispettiva carena per le onde marine, che potrebbe apparentemente celebrare la grandezza dell’ingegno umano, in realtà sancisce il termine della cosiddetta età dell’oro. L’epoca più felice e spensierata viene stravolta dalla tracotanza dell’uomo, che viola la natura e i suoi equilibri, interviene a modificarne l’ordine. Squarciare la terra e il mare significa ferire, introdurre il male nel mondo, emanciparsi dalla natura e determinare così la solitudine dello stesso agire umano. Dunque l’aratro ricorre notevolmente nei testi degli antichi e nelle loro tradizioni, in particolar modo nei racconti delle origini dell’uomo, delle società, delle città, delle civiltà. Si pensi alla fondazione di Roma e al solco rituale scavato da Romolo e interrotto da Remo; quest’ultimo verrà poi sacrificato contro la volontà e l’affetto del fratello per consentire la lecita prosecuzione, da quel momento in poi solitaria e fratricida, dell’urbigonia. Oppure si può ricordare l’episodio presente nel Ciclo Troiano, più specificatamente nei Cypria, che vede come protagonista Odisseo e il suo tentativo di diserzione dalla spedizione panellenica contro Troia. Questi, con l’intento di fingersi folle, aveva iniziato ad arare la spiaggia di Itaca, seminando tra la sabbia e le onde. Naturalmente l’astuzia poi sventata da Palamede, che pose di fronte all’aratro Telemaco, il figlioletto in fasce di Odisseo, nacque nell’ottica di provare a salvarsi da vent’anni di dolore, di solitudine e abbandono per Odisseo stesso da un lato e per Penelope, Telemaco e Itaca dall’altro.

Dopo questa premessa, ci soffermiamo sul confronto di due liriche in particolare che s’incentrano sulla simbologia dell’aratro, gli esempi più noti e celebri della nostra letteratura della classicità e della modernità: il Carme 11 di Catullo in strofe saffiche e il madrigale Lavandare di Pascoli.
Quest’ultimo componimento risulta essenzialmente descrittivo e statico; i soggetti logici si dividono le due terzine: nella prima l’aratro Nel campo mezzo grigio e mezzo nero / resta un aratro senza buoi, che pare / dimenticato, tra il vapor leggero e nella seconda le lavandare E cadenzato dalla gora viene / lo sciabordare delle lavandare / con tonfi spessi e lunghe cantilene. La quartina finale racchiude proprio le cantilene popolari che accompagnavano l’attività delle donne addette a lavare i panni nei canali accanto ai campi. L’ispirazione del poeta proviene dai Canti popolari marchigiani, raccolti da Antonio Gianandrea nel 1875. Da Retorna, Amore miè, se ci hai speranza, / per te la mia vita fa penetenza! / Tira lu viente, e nevega li frunna, / de qua ha da rveni’ fideli amante e Quando ch’io mi partii dal mio paese, / povera bella mia, come rimase! / come l’aratro in mezzo alla maggese Pascoli fedelmente ricava: Il vento soffia e nevica la frasca, / e tu non torni ancora al tuo paese! / Quando partisti, come son rimasta! / come l’aratro in mezzo alla maggese. La conclusione ciclica permette di esplicitare la similitudine tra l’aratro e la donna. La donna viene abbandonata, come l’aratro in un terreno lasciato a riposo, in maniera repentina e inaspettata, tant’è che l’aratro resta nel mezzo della sua opera in un campo dissodato solo in parte. Allo stesso modo, la donna si sente ripudiata nel pieno dei progetti, dei piani, dei sogni per metà realizzati e per metà no. L’esistenza si incaglia in questo dislivello. Sente la mancanza di tutto ciò che ancora non ha vissuto, ma che avrebbe voluto. È la drammaticità della perdita, della solitudine, posta nel mezzo, tra passato e futuro, a guardare verso i ricordi nostalgici per la loro bellezza e verso ciò che non si è vissuto, verso i rimpianti, l’incompiuto, i dolori. E si vede sottratto ogni forma di presente, da quel vapore leggero, che obnubila e annebbia tutto, rendendo vana ogni parola di conforto e consolazione proveniente dalla ragione o dal cuore. Il canto popolare, che fa da sfondo al madrigale, ne è in realtà protagonista; concettualmente rappresenta la voce intima dell’abbandono che tende a ripetersi continuamente le stesse cose, in preda al dolore e alla malinconia struggente. La ciclicità è la nenia, la sua percussività è il tormento che ritorna e non lascia andare, che ossessiona. È il senso di mancanza asfissiante che urge dell’essere riempito sempre con le stesse parole, con lo stesso conforto, però senza trovare soluzione, tant’è che Quando partisti, come son rimasta! oppure e tu non torni ancora al tuo paese! sono esclamazioni a senso unico di folle sofferenza, autocommiserazioni, quasi vittimismo che non conforta ma infligge ancora più patimento.

Nel carme catulliano l’aratro è invece in movimento, circondato da uno sfondo naturalisticamente vivo, ed è fautore e colpevole di solitudine e abbandono, non più attorniato da un contesto morto e sterile, non più incarnando l’abbandono in atto con tutte le sue conseguenze, quali le angosce, i tormenti, le preoccupazioni, le paure, i traumi. In Catullo è l’addio definitivo d’un amore. Riguardo a tale amore si esplicita anche l’erotismo, non più connesso al poeta ma a nuovi amanti: Viva pure felice e si goda i trecento suoi amanti / che insieme è capace di stringere a sé tra le braccia / senza amarne nessuno davvero, e a vicenda fiaccando / le reni a tutti. L’iperbolica lussuria, come poi vedremo simboleggiata dall’aggressività dell’aratro, in realtà ci lascia il dubbio che il poeta abbia compreso quanto la sua donna Lesbia sia incapace di bene velle, dando importanza esclusivamente all’aspetto sessuale e scherzando con quello emotivo e sentimentale. Mentre in Pascoli l’aratro ricorre in un contesto di erotismo represso: la terra viene ferita dal vomere dell’aratro, come la donna stessa dal sesso dell’uomo e così viene poi abbandonata, come se in parte fosse stata violata ma non del tutto. Tale visione richiama sicuramente il pensiero morboso e malato che Pascoli aveva sulla sessualità. La donna, come la terra, rimane gualcita, violata, sola con la propria fragile emotività ad affrontare le conseguenze dell’amore carnale e sentimentale.
Possiamo concludere con l’ultima strofa catulliana, quasi orfica, E non si volti a guardare, come un tempo, il mio amore / che per colpa sua è caduto come il fiore / del margine del prato dopo che è stato toccato / dall’aratro che passa oltre. L’elenco iniziale magniloquente dei popoli e dei territori estremi a cui gli amici del poeta dovranno dare l’annuncio della sua volontà a interrompere e dimenticare il suo amore si chiude in una scena elegiaca, denotata da un contesto intimo e privato. Pertanto la dimensione agreste e bucolica, per un latino repubblicano di provincia, ha un forte valore capace di evocare quotidianità, privatezza, universo domestico; ed è proprio tutto ciò ad essere stato ferito e lacerato nel suo valore intimo. Rispetto ad un passato felice per la passione amorosa, a cui ci si riferisce con nostalgia ma anche con risolutezza, la donna amata abbandona volontariamente il poeta, il quale vorrà poi prenderne le distanze per il male subito, passivamente, innocentemente. Il fiore, che simboleggia il vigore entusiasta e puro del sentimento di Catullo, è quello del margine del prato, come a segnalare che nulla rimane dell’amore dopo l’addio netto e definitivo, nemmeno un’illusione. L’aratro così tocca il fiore, modifica il suo equilibrio cioè stravolge indelebilmente la sua esistenza, per poi nel suo fatale passare oltre, abbandonarlo impietoso, inesorabile, indifferente.