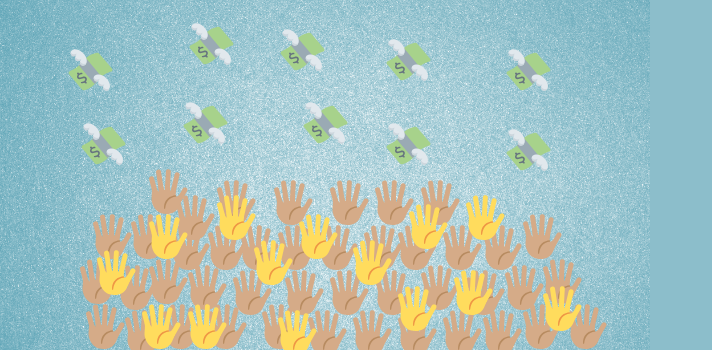L’amore a tempo determinato – il divorzio in Italia
Con la legge n°898/1970 si introduce in Italia l’istituto del divorzio, già accolto precedentemente in altri Stati europei – un momento di rottura culturale non da poco, in un Paese in cui il più forte ostacolo a una simile novità era senz’altro costituito dal genetico radicamento, anche a livello istituzionale, di una coscienza sacrale dell’istituto del matrimonio che non poteva ammetterne la dissolubilità. Il richiamo alla visione cristiana del matrimonio si scontrava però con l’ideologia progressista dei socialisti come del Movimento Sociale Italiano, dei Repubblicani e del movimento femminista, il che ha comportato dissidi tali da sollecitare, nel 1974, un referendum abrogativo della legge sopracitata. Ma il passo epocale era stato oramai compiuto: con una partecipazione alle urne dell’87,7% degli aventi diritto ed il 59,3% dei voti favorevoli al mantenimento dell’atto normativo, quel 12 maggio il divorzio è stato definitivamente recepito nel nostro ordinamento.
Occorre preliminarmente intendersi sulla terminologia. Il divorzio – già noto agli antichi Romani, che invero distinguevano il divortium bilaterale dal repudium unilateralmente esercitato dal marito nei confronti della moglie, attraverso l’enunciazione di una determinata formula rituale per tre volte in luogo pubblico – non corrisponde affatto alla separazione personale dei coniugi, già disciplinata dal codice civile del 1942 e che consiste in un mutamento del rapporto matrimoniale nei suoi profili affettivi e patrimoniali: con essa cessano in particolare l’obbligo di fedeltà e coabitazione sanciti dall’articolo 143 c.c. e viene istituita una separazione dei beni le cui condizioni dipendono dalla natura dei rapporti economici vigenti in costanza di matrimonio (non è mai superfluo rammentare, peraltro, che suddetti profili economici, le convenzioni matrimoniali, sono sempre stipulati a latere del patto matrimoniale, il quale è di per sé un negozio giuridico e semmai un sacramento ma non un contratto). La separazione personale si configura dunque come una situazione transitoria che trova il suo esito nella riconciliazione dei coniugi oppure, per l’appunto, nel divorzio.
Se il matrimonio è stato celebrato con rito religioso (c.d. matrimonio concordatario), la procedura divorziale comporterà la cessazione dei suoi effetti civili, mentre essa agirà sul matrimonio civile (non religioso) sciogliendone il vincolo.
Ex facto oritur ius. Dove rintracciare le cause, prossime o remote, di un cambiamento irreversibile e culturalmente così drastico?

Ebbene, la migliore sociologia americana degli anni ‘50 (che in questa sede assumiamo come paradigmatica vista la sua riconosciuta capacità di analisi sociale, più volte mostrata) direbbe che il mutare delle condizioni di vita e di lavoro in Occidente all’indomani della II Guerra Mondiale ha innescato un processo di sostanziale erosione dell’assetto patriarcale della famiglia, ancorata ai valori della tradizione e alla genealogia, la quale è andata progressivamente riducendosi ad un modello c.d nucleare (T. Parsons, Famiglia e socializzazione, 1955), caratterizzato da un padre/marito per così dire bread-winner – dunque fonte principale se non esclusiva delle risorse materiali indispensabili al consorzio familiare –, da una moglie essenzialmente casalinga e da uno o due figli. Un passo ulteriore è consistito nell’ammettere che all’interno del modello nucleare la donna stava guadagnando una maggiore autonomia, dovuta al suo poter essere non solo casalinga, ma anche una lavoratrice posta sullo stesso piano del marito.
Di fatto, la legislazione italiana sul divorzio fa sue non solo simili acquisizioni sociali e strutturali, ma si spinge più in là riconoscendo che nessun uomo può oscurare la dignità e le capacità intellettive della donna. Dietro quel 59,3% di favorevoli alla legge, insomma, vi sono uomini coscienziosi che non tollerano il soffocamento delle virtù femminili, liberali la cui categoria interpretativa della società è l’individuo – non già la coppia – con i suoi diritti, donne stanche di abusi domestici legittimati dai falsi preti dell’indissolubile vincolo, e infine socialisti che al libero amore, quand’anche nelle sue nuances libertine, hanno invece sempre creduto.
 Ciò che agli occhi del Vaticano parve uno strappo intollerabile, fu da molti salutata come una scelta risolutiva. Ma risolutiva di che cosa, in fondo? Certamente di un rapporto coniugale che si sarà rivelato precario, di un’illusione d’amore che col tempo evidentemente è svanita, di una comunione fisica e spirituale che adesso non c’è più, o che molto più coerentemente non dev’esservi mai stata. Friedrich Nietzsche in questo era stato chiaro: sono fallibili i comportamenti, i comportamenti non sono coerenti, possono cadere nel giusto o nell’errore; non così però la scintilla dell’autentico amore tra due individui, fondato sul rispetto. Ciò che si compie per amore, egli dice, è sempre per essenza al di là del bene e del male, e quel sentire autentico, pare evidente anche a noi, quello non può essere sciolto nemmeno da un divorzio.
Ciò che agli occhi del Vaticano parve uno strappo intollerabile, fu da molti salutata come una scelta risolutiva. Ma risolutiva di che cosa, in fondo? Certamente di un rapporto coniugale che si sarà rivelato precario, di un’illusione d’amore che col tempo evidentemente è svanita, di una comunione fisica e spirituale che adesso non c’è più, o che molto più coerentemente non dev’esservi mai stata. Friedrich Nietzsche in questo era stato chiaro: sono fallibili i comportamenti, i comportamenti non sono coerenti, possono cadere nel giusto o nell’errore; non così però la scintilla dell’autentico amore tra due individui, fondato sul rispetto. Ciò che si compie per amore, egli dice, è sempre per essenza al di là del bene e del male, e quel sentire autentico, pare evidente anche a noi, quello non può essere sciolto nemmeno da un divorzio.