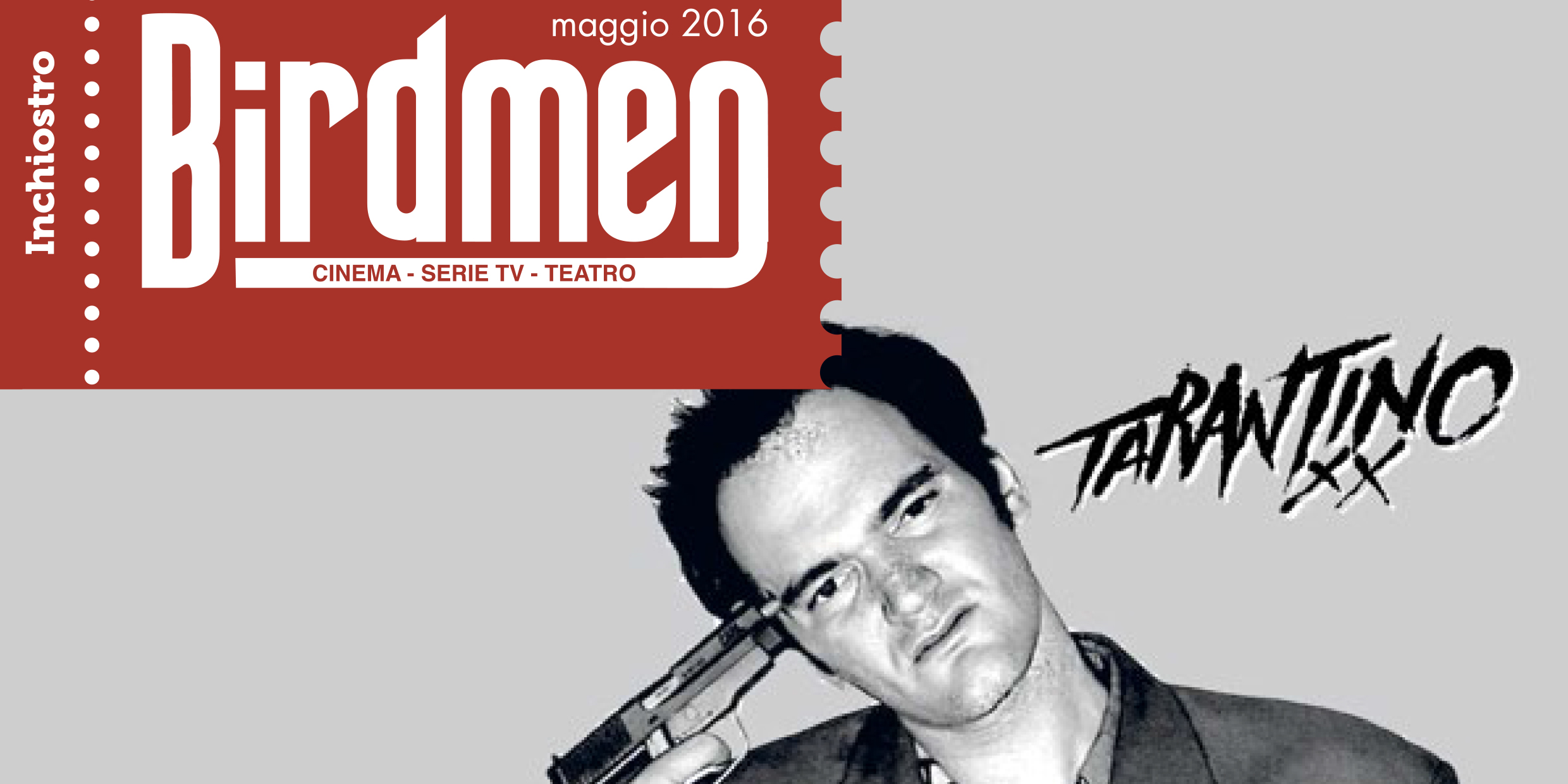La Balkan Route: una ferita al cuore dell’Europa
Avviene sempre così. Perché un fatto ci interessi, ci commuova, diventi una parte della nostra vita interiore, è necessario che esso avvenga vicino a noi, presso genti di cui abbiamo sentito parlare e che sono perciò entro il cerchio della nostra umanità. È un gran torto non essere conosciuti. Vuol dire rimanere isolati, chiusi nel proprio dolore, senza possibilità di aiuti, di conforto. Per un popolo, per una razza, significa il lento dissolvimento, l’annientarsi progressivo di ogni vincolo internazionale, l’abbandono a se stessi, inermi e miseri di fronte a chi non ha altra ragione che la spada.
Così scriveva Antonio Gramsci su Il Grido del popolo l’11 marzo 1916 in merito al genocidio armeno. Pur essendo state scritte un secolo fa queste parole oggi sono più attuali che mai.
Sulle montagne bosniache, in Europa, a mille chilometri dall’Italia i migranti marciano a tappe forzate, sottoposti alle minacce delle polizie locali e della criminalità organizzata. Non ci sono barconi in mezzo al mare, non ci sono scafisti: non solo il Mediterraneo è un cimitero a cielo aperto, c’è anche la rotta balcanica tra le vie d’ingresso in Europa di migranti e richiedenti asilo. Nel corso degli ultimi cinque anni sono state centinaia di migliaia le persone fuggite dai loro Paesi in difficoltà, in guerra o a causa di persecuzioni e transitate attraverso i Balcani.
Nel 2020 circa 80mila migranti sono registrati in transito lungo questa regione balcanica nel tentativo di raggiungere l’Unione Europea, 119mila sono presenti i Grecia e circa 4 milioni di rifugiati e richiedenti asilo sono bloccati in Turchia. Un flusso continuo di persone che le politiche migratorie europee e l’accordo UE-Turchia non sono riusciti ad arrestare dato che i paesi di provenienza, in particolare in Siria e in Afghanistan, permangono gravissime situazioni di crisi, e al contempo la rotta del Mediterraneo centrale è diventata molto più pericolosa a causa della guerra in Libia e dei respingimenti in mare.

Dopo l’incendio a Lesbo nel campo di Moria nel settembre del 2020, l’inverno ha aperto un nuovo fronte di crisi in Bosnia Erzegovina. A rendere più complessa la situazione, dal febbraio scorso, è la pandemia, che ha portato i paesi di transito a isolare ancor di più i profughi, a collocarli in campi distanti dai centri abitati, per ridurre il rischio della diffusione del contagio. È avvenuto a Lipa, località di montagna distante circa trenta chilometri dalla città di Bihac e al confine con la Croazia.
Per riuscire a comprendere meglio la situazione abbiamo intervistato Don Dario Crotti, cappellano del carcere di Pavia ed ex direttore della Caritas.
-Don Dario, raccontaci la tua esperienza in Bosnia come volontario.
Tutto è partito nell’ottobre 2018. L’inizio della mia esperienza è da ricollegare alla guerra dei Balcani: le Caritas italiane si attivarono per realizzare i gemellaggi, cioè l’affiancamento a una diocesi locale per realizzare, nel conflitto e anche nel periodo post bellico, attività che potessero offrire una risposta ai bisogni immediati della popolazione ma anche un aiuto per curare le ferite della guerra. Una diocesi della Bosnia, quella di Banja Luka aveva fatto tante attività con la Caritas di Mantova. L’ex direttore della Caritas di Mantova mi chiamò e mi disse che la diocesi di Banja Luka, con cui c’era stato un rapporto importante negli anni della guerra, stava attraversando diverse difficoltà perché nel suo territorio, al confine con la Croazia, c’era un arrivo esorbitante di persone che facevano la tratta, cioè la rotta dei Balcani, per arrivare in Europa. E allora ci hanno chiesto una mano e ci hanno invitati a vedere la situazione. Lì c’era già un presidio di Caritas italiana, Daniele Bombardi è un volontario che ormai vive lì e ci siamo coordinati con lui e con IPSIA (Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli), la cui referente è Silvia Maraone. La prima volta, quindi, sono andato con due mantovani e con un paio di giovani pavesi e abbiamo fatto il sopralluogo di alcuni campi che ospitavano i migranti. Alcuni erano abbastanza attrezzati perché organizzati dalla municipalità, dalla Croce Rossa e da IPSIA, altri totalmente autonomi dove si portavano solo beni di prima necessità. Nel 2019 sono tornato per un paio di visite, quindi in tutto ci sono stato tre volte. Dopo queste esperienze ho riportato alle Caritas lombarde la situazione e si è finanziato un progetto di circa 50.000 euro, poi c’è stata qualche raccolta spontanea fino ad arrivare a questo inverno dove si è deciso di organizzare un progetto con l’università.
-Come si vive nei campi profughi? In particolare qual è la situazione delle categorie più fragili: anziani, bambini e disabili?
Nei campi si vive in tende, in condizioni misere. Un’immagine che mi porto dietro è l’arrivo in un campo di un megageneratore, c’era una tenda solo per caricare i telefoni che erano centinaia e veniva alimentato a benzina. Il telefono per chi percorre la rotta dei Balcani è vitale, ha dentro il gps per segnare i percorsi e i sentieri per arrivare in Croazia, e serve anche a comunicare con la famiglia. Nell’ultimo anno c’è stato uno smantellamento dei campi governativi e questo la dice lunga sulla politica di questi paesi, nella prima visita eravamo sconvolti per il campo di Borici, era un ex studentato, non completato a causa della guerra, era rimasto semi costruito, molto fatiscente. Era il peggiore di tutti, poi il governo ha realizzato un progetto inserendo lì le mamme con i bambini, quindi da questo punto di vista un minimo di attenzione c’è.
Di anziani ce ne sono pochissimi perché il viaggio è troppo lungo, i migranti camminano a piedi dal Pakistan, dall’Afghanistan, anziani non ne ho visti, non si mettono in viaggio perché magari non riescono nemmeno ad arrivare sani e salvi. Bambini piccoli ce ne sono tanti perché vengono portati dalle famiglie, ma l’anziano non parte, non riuscirebbe a fare quello che loro chiamano game, che significa gioco, ma è tutt’altro che questo. Consiste nel salire le montagne croate per arrivare in Europa, ma spesso la polizia croata li respinge indietro con violenza.
L’ultima volta che sono stato prima della pandemia, a ottobre 2019 abbiamo trovato un campo autogestito dove c’era una miseria assurda, io sono stato anche in Africa e non avevo mai visto niente del genere. L’unico motivo di esistenza di questo campo era la sua collocazione, si trovava infatti ai piedi dei monti da cui si partiva per fare il game. Quel campo era un’ex fabbrica e il governo lo stava smantellando per dare un messaggio positivo alla gente del posto che si lamentava, dimostrando così che le cose non sarebbero durate a lungo. E la cosa pazzesca che ho visto erano le fila di giovani che venivano portati via dal campo e deportati per più di 8 km nei monti dove non c’era nulla, nemmeno l’acqua, al massimo qualche tenda della Croce rossa per un primo soccorso.

-Quanto tempo trascorrono nei campi?
Cercano di starci il meno possibile. Appena hanno ripreso le forze tentano il game. Rimangono circa 6, 7 ma anche 8 mesi, chi è fragile anche di più. Qualche parente manda qualche soldo, qualcuno si trova qualche attività facendo un mercatino. La partenza di molti migranti è un investimento per la loro famiglia ma anche per il loro villaggio, li sostengono perché se a uno di loro il viaggio va bene, riesce ad arrivare in Europa poi manda i soldi del nel suo Paese di origine e mantiene la famiglia. Dietro qualcuno che parte c’è un investimento di una famiglia e di un villaggio.
-Quali sono le storie, le immagini che più ti hanno colpito?
L’ultima volta che sono andato, nell’ottobre del 2019 è venuto con me Don Maurizio, il direttore della Caritas di Brescia, e un operatore della Caritas di Lodi. Era un ottobre particolarmente caldo, per questo c’erano un sacco di partenze per il game. Un pomeriggio, un martedì, nel campo arriva una coppia bellissima di afghani, giovani ventenni con un cestino con la loro bambina appena nata, si sarebbero appostati nel bosco e poi di notte avrebbero provato la traversata dei monti. Il giovedì verso le 23.30 Don Maurizio mi manda un messaggio e mi chiede di raggiungerlo, e scoppia a piangere perché si chiedeva se quei due ragazzi giovani con quella bambina così piccola ce l’avessero fatta o meno. È stato un momento forte in cui ci siamo resi conto di quanto sia assurdo tutto questo. La bambina avrà avuto due mesi questo significa che la ragazza aveva partorito durante il viaggio. Erano un ragazzo e una ragazza belli, non solo nei lineamenti ma anche speranzosi, luminosi, pieni di risorse.
Un’altra cosa che mi ha colpito profondamente sono i piedi di questi giovani, erano disfatti per tutti i chilometri che avevano fatto, non avevano certo l’attrezzatura che abbiamo noi quando andiamo a camminare in montagna. La prima cosa che facevano era andare dalla Croce Rossa a farseli medicare. E avevo notato che avevano uno straccetto e appena le scarpe si bagnavano o infangavano le pulivano. Il valore che loro danno alle scarpe è lo stesso che noi daremmo a un suv, le tenevano con una cura impressionante.
-Come opera la Caritas sul territorio? Quali progetti vengono portati avanti?
Da un lato porta avanti un’azione diretta per i beni necessari e fondamentali per la sopravvivenza, la legna per scaldarsi, coperte, docce, lavatrici, sistemi per poter garantire l’igiene perché la scabbia si diffonde velocemente. Inoltre porta avanti un’azione di sensibilizzazione anche con la politica locale per la tutela dei diritti, è un’azione a 360 gradi.

Non solo la testimonianza di chi è stato lì come Don Dario, ma anche le immagini che ci arrivano di centinaia di donne, uomini, bambini senza riparo, al freddo, bloccati fra Paesi che li respingono con la violenza e senza nessun rispetto, vanno a colpire direttamente le nostre coscienze.
Noi studenti non potevamo restare a guardare e così si è deciso di organizzare una raccolta fondi attraverso la piattaforma universitiamo.eu. Il progetto Un ponte oltre l’indifferenza. Sguardi alle persone sulla balkan route è sostenuto dall’Università di Pavia e in particolare dai collegi. Per capire meglio di cosa si tratta abbiamo intervistato Laura Pesenti studentessa di medicina e alunna del collegio Santa Caterina.
-Com’è nato il progetto?
Una ragazza del mio collegio ha proposto di fare una raccolta fondi per la Bosnia. Io e un altro paio di ragazze facciamo volontariato con alcuni ragazzi stranieri a cui insegniamo l’italiano e abbiamo conosciuto la realtà della tratta dei Balcani proprio dalle persone che aiutiamo. Poi ci è venuto in mente che per fare una cosa più in grande si potevano coinvolgere gli altri collegi. Per questo abbiamo pensato a Dove c’è bisogno che io porti un aiuto che è un progetto, coordinato dal Prof. Giuseppe Faita, che aveva coinvolto la Caritas nel periodo del primo lockdown e già raccoglieva tanti studenti universitari e collegiali. Abbiamo partecipato a una riunione di quel gruppo di volontariato e abbiamo proposto la raccolta fondi. E quindi abbiamo iniziato a lavorarci coinvolgendo gli studenti universitari e in particolare i collegiali.
-Quali obiettivi si pone?
Si può donare attraverso la pagina di universitiamo.eu dove c’è una descrizione dettagliata del progetto (https://universitiamo.eu/campaigns/un-ponte-oltre-lindifferenza/) e i fondi sono destinati a Caritas italiana in Bosnia che attraverso Daniele Bombardi, volontario che vive lì stabilmente, riesce a gestire i fondi nel modo più opportuno, leggendo le necessità del momento. Lo scopo del progetto è quello di dare un aiuto concreto ma anche sensibilizzare sul tema attraverso dei cicli di conferenze.

-Quale significato vuole esprimere il logo che avete scelto?
Il logo è stato realizzato da un ragazzo del Maino, c’è un cerchio di mani che sta ad indicare la vicinanza e l’unione, si voleva anche rappresentare un simbolo di Pavia e si è scelto il ponte coperto, che sta ad indicare un legame. A me piace vederlo come un ponte tra noi universitari che siamo privilegiati e possiamo inseguire i nostri sogni senza troppe difficoltà e i nostri coetanei che solo perché nati in un altro Paese non hanno questa possibilità, non possono crearsi la vita che vorrebbero.
Laura è andata come volontaria durante le vacanze di Natale 2019-2020 in due campi di cui uno di minori non accompagnati in Bosnia con IPSIA, qust’ultimo ospitava circa 400 persone e ci ha raccontato le immagini che le sono rimaste nel cuore.
“C’erano tantissime famiglie con tanti bambini e tante donne incinte, c’era una signora che aveva un bambino disabile di circa 8 anni e portava anche il bambino nelle attività che facevamo solo con le donne, lo mettevamo sul tavolo con una coperta e stava lì e sorrideva. Per trasportarlo questa signora aveva un passeggino che sembrava quasi un giocattolo non adatto a un bambino del genere che sicuramente doveva avere un supporto per la testa e per il collo, e questo mi aveva colpito molto.
Un legame che porterò sempre con me è l’amicizia con un ragazzo egiziano che sento ancora e si trova attualmente nel campo. Sono passati già 1 anno e 4 mesi, prima di giocare con noi andava a chiamare la sua famiglia e tornava con gli occhi lucidi perché aveva pianto. Vorrebbe diventare medico come me e mi dice sempre che io ce la farò, lui chissà. Mi sono resa conto del fatto che tantissimi ragazzi afghani avevano voglia di fare, di arrivare, di realizzare i sogni per cui sono partiti. Il confronto è stato devastante perché sono miei coetanei e non hanno niente.
Mi ricordo poi due ragazzi, uno afghano e iraniano che costruivano tutti i giorni gli aquiloni perché nel loro paese è un gioco molto popolare, e li costruivano con i rametti e con i sacchi della spazzatura e riuscivano a farli volare. Mi hanno aiutato a costruire il mio che, dopo qualche difficoltà, è salito su in cielo. Uno di loro l’ultimo giorno, prima di tornare in Italia, mi ha regalato quell’aquilone che conservo ancora adesso”.

Ci vuole fortuna a nascere, a nascere nel posto giusto del mondo, nessun merito ma solo fortuna. Chi ha letto (o visto il film) Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini può ben immaginare cosa spinga questi giovani a rincorrere i loro sogni e le loro speranze lungo la Balkan route: Spero che un giorno nel nostro Paese torni la pace e si possa tornare a sentire nelle strade il profumo del thè.
Foto copertina via Reuters