In che luce cadrà – intervista a Gabriele Galloni.
Gabriele Galloni è nato a Roma nel 1995. Nel 2017 ha pubblicato Slittamenti, con una nota di Antonio Veneziani (Augh! edizioni); nel 2018 è uscito In che luce cadranno (RPlibri). Cura per Pangea la rubrica Cronache dalla fine, dodici conversazioni con altrettanti malati terminali. Ho avuto l’onore di intervistarlo per Inchiostro all’interno della nostra intermittente rubrica di interviste ai poeti (recentemente, Gianni Montieri sulle domande di Davide Spinelli.
Chi mi divide dai nipoti di Adamo. Credo fosse Tasso a dirlo, in qualche prosa, forse nei Discorsi. Ho pensato alla tua poesia, che ha una certa volontà di distacco dai modelli. Che pessima parola. Chiamiamoli coerentemente: i morti. Che rapporto hai coi morti in poesia? A me è parso un distacco, da Caproni sicuro e poi da un’idea soprattutto di poesia, come per quei poeti che isolano un segmento e lo estendono – di un testo – fino a farlo coincidere con la realtà. Impressione la mia.
I nipoti di Adamo non sono i nostri simili, ma coloro che di vita in vita attendiamo senza che arrivino mai. Non penso di essere immodesto nel definire la mia poesia (almeno quella di In che luce cadranno, per Slittamenti è un altro discorso) come autonomo Verbo, slegata da riferimenti e modelli precisi. Forse lo spettro del Toulet più epigrammatico, in controluce, ma per il resto ho tenuto le mie letture amate il più lontano possibile. Tant’è che ora come ora mi risulta difficile parlare di modelli. Forse questa è stata la risoluzione del mio confronto con i morti, del mio rapporto con loro in poesia: non dovere più niente a nessuno, ogni debito saldato. Scrollarmi dalle spalle la polvere dei tributi e della riverenza. È cosa buona, ogni tanto, cancellare per gioco le iscrizioni funebri. I morti non ne hanno alcun bisogno.
 Slittamenti è il primo libro che hai pubblicato, ma è un processo successivo. Da quando l’ho letto ogni volta che scrivo ricordo la P maiuscola di Parola. Lì c’erano molti dialoghi e in realtà il dialogo, qui, è la clausola contrattuale per cosa? Direi per la coincidenza essenziale fra durata del discorso poetico e durata del momento. Dici a un “tu” di non lasciare che il tempo conti quante volte ci siamo e perciò lo isoli? Lo rappresenti inevitabilmente nella sua scorribanda verso la fine? Chatman dice che la felice vittoria della materia narrativa (esistenti, ambienti, eventi) è nel chiudersi ancora nella vitalità di un racconto. È questo? E comunque c’è anche tempo immobile nella raccolta.
Slittamenti è il primo libro che hai pubblicato, ma è un processo successivo. Da quando l’ho letto ogni volta che scrivo ricordo la P maiuscola di Parola. Lì c’erano molti dialoghi e in realtà il dialogo, qui, è la clausola contrattuale per cosa? Direi per la coincidenza essenziale fra durata del discorso poetico e durata del momento. Dici a un “tu” di non lasciare che il tempo conti quante volte ci siamo e perciò lo isoli? Lo rappresenti inevitabilmente nella sua scorribanda verso la fine? Chatman dice che la felice vittoria della materia narrativa (esistenti, ambienti, eventi) è nel chiudersi ancora nella vitalità di un racconto. È questo? E comunque c’è anche tempo immobile nella raccolta.
Il dialogo, nei versi di Slittamenti, era l’unico modo per dire qualcosa che, fuori dalle virgolette, sarebbe stato precario; forse stucchevole. Così, invece, ha il tono della profezia. O dell’allucinazione. Ecco, vi ho rivelato un trucco carino. Quando sentite, scrivendo i vostri versi, il bisogno di una svisata improvvisa, fingetela dialogo o monologo. Camuffatela bene – virgolettata o in corsivo, mi raccomando. Nessuno potrà accusarvi di dispersione. Anzi, l’intromissione di un eventuale invisibile personaggio narrante, farà sembrare la vostra poesia molto più arguta e interessante di quanto non sia in realtà.
In Slittamenti c’è molta narrativa. Il poeta Fernando Acitelli, parlando del mio esordio, ha detto che esso conteneva – frammentato in tante piccole immagini – un romanzo fiume. In quei giorni non avrebbe potuto farmi complimento più bello. Forse è questa frammentazione, Demetrio, che ti ha fatto pensare al tempo immobile. Delle polaroid, dei brevi flash a eternare il minimo: un palazzo, un omicidio, un coito, una eiaculazione.
In che luce cadranno. Per RP, 2018. Un libro, non vorrei esagerare, non su una società di morti ma sulla socialità dei morti, il loro mutismo. In primis, c’è legame con l’effluvio di parola dell’altra raccolta? In secundis, cosa dicono, i morti?
Quasi nulli i legami con Slittamenti. Nessuno sul piano concettuale; pochi sul piano stilistico. In Slittamenti ero ancora influenzato – ma per fortuna senza l’estrema pedanteria di alcuni miei coetanei, alla lontana – dalle scorie nefaste del tardo novecento post Raboni. Tutto questo bisogno di impalcature, di inettitudine formale e concettuale; la poesia come scheletro di palazzo in costruzione. In molti scrivono versi solo per leccare il culo ai cosiddetti grandi vecchi; per soddisfare l’ego di questi nonnoni, mostrarsi loro diretti discendenti e ottenere qualche briciola di vantaggio personale. Non che il mio intento con Slittamenti sia stato questo, per carità. Ma certe influenze, lì, a tratti si fanno troppo scoperte. Di quel libro salvo una ventina di poesie, niente di più. Non mi azzarderei mai ad avvicinarlo ai miei lavori successivi.
Invece i morti. Dunque cosa dicono. Più o meno le nostre stesse cose. Quindi niente di così importante o trascendentale. È più interessante, invece, ricostruire la geografia immaginaria dei morti. Descrivere i loro continenti, i loro giardini a noi sconosciuti. E di riflesso le loro abitudini. Il pane che spezzano guardandosi i piedi; il coito che portano a termine sotto la luna; e la luna che loro odiano e considerano sgarbata. Il loro sesso di latte tra le rocce calcaree.
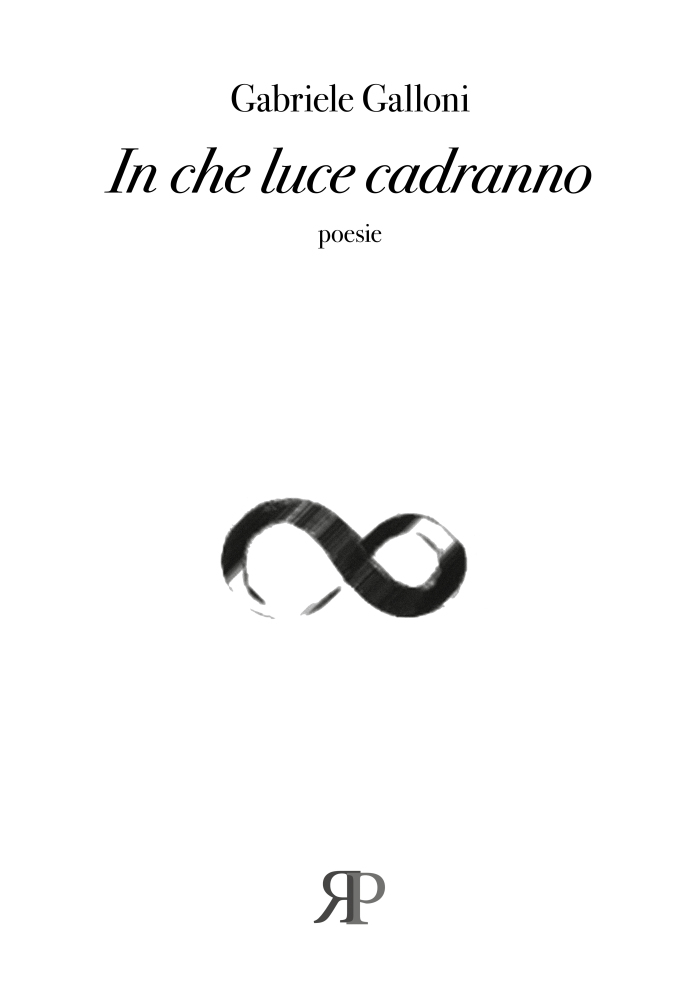 Può capitare che i morti si filmino a vicenda. Scrivi. Mi pare bene insistere sulla sensibilità dei morti, cioè sulla loro individuale percezione, e reciproca. Decade presto. Tutto mi sembra ricondurre i morti a simbolo o trasposizione dei vivi ma non vorrei banalizzare. Certo, non sarei sorpreso, leggendoti giornalmente sui social, se mi dicessi che sottotraccia c’è una certa verve polemica. Vorrei chiederti se c’è e se c’è altro (che sono convinto) che la mette in secondo piano.
Può capitare che i morti si filmino a vicenda. Scrivi. Mi pare bene insistere sulla sensibilità dei morti, cioè sulla loro individuale percezione, e reciproca. Decade presto. Tutto mi sembra ricondurre i morti a simbolo o trasposizione dei vivi ma non vorrei banalizzare. Certo, non sarei sorpreso, leggendoti giornalmente sui social, se mi dicessi che sottotraccia c’è una certa verve polemica. Vorrei chiederti se c’è e se c’è altro (che sono convinto) che la mette in secondo piano.
No, nessuna verve polemica. Il binomio morti-vivi lo trovavo stucchevole già a dodici anni. La polemica, tranne in rari casi, non sostiene la causa dell’espressione creativa. Ho immaginato un universo, con In che luce cadranno, che avesse il perimetro di una stanza ma la capienza degli oceani. Forse perché i morti – come sostenevano alcuni eretici – devono piuttosto inabissarsi che ascendere al cielo. Sondare lo sprofondo marino e preferirlo alle nuvole. Ecco perché capienza di oceano e non di cielo. Questa idea di universo è stata la stella-guida che ho sempre tenuto davanti a me durante la scrittura di In che luce cadranno. I morti, nel mio libro, non sono speculari a noi vivi. I morti sono i morti – una civiltà come un’altra. Con i loro usi, costumi, deficit e sessualità.
Un corpo morto non è abbandonato. | Ignora – è verità – le altre creature; | ignora i diktat dell’eternità. | Ma stanne certo: un giorno tornerà | alla vita e avrà voce di Creatore. Ancora la voce e l’eternità. E poi la sconfessione di questo continuo rivolgersi tra corpi (l’ignorare l’alterità). Mi sembra che la tua poesia giochi su Leitmotiv molto forti, quasi formulari che mi spingono a pensare a una liturgia dissacrale. C’è religione (perlomeno assolutamente laica se non meglio una religiosità atea) nella tua poesia?
Ecco, hai tirato in ballo una questione molto interessante. Intendo la mia poesia come profondamente religiosa – una religiosità, tuttavia, assai problematica. Si può parlare di Fede (e non è un atto di fede teorizzare in versi una civiltà di morti?) ma non come appiglio o punto di riferimento.
Esiste il costato divino da lacerare, la ferita da allargare. E il costato, la ferita siamo noi. Non siamo più dalla parte di Tommaso e del suo dubbio. Noi siamo la carne aperta – e la Fede, e per esteso l’Altro, è l’arto che ci penetra e ci esplora. E noi possiamo abbandonarci, accogliere immobili; possiamo assecondare o ribellarci, far sì che la mano ci stupri, ci dissacri. Far sì che arrivi fino agli organi soltanto per strizzarceli. Oppure rigettare la mano, lavorare di muscolo e impedirle di superare l’apparenza della pelle rotta. Questi i termini della mia religiosità. Un background cattolico obliquo, vero? Quindi sì, molta religione. Ma religione di lotta, di interrogativi laceranti e di vuoti assoluti. Non a caso combatto sempre con l’Angelo – e uno dei due dovrà presto uccidere l’altro. L’Altro.
Cosa pensi della letteratura contemporanea? E dei social? Mi sembra una domanda di default ma credo sia obbligatoria. Sembra che per te sia una sorta di fantastico spazio editoriale perenne. Anche altri poeti quasi separano la produzione social da quella privata (che poi non è privata ma pubblica dopo tempo di prescrizione), è così per te?
Partendo dalla prima domanda. L’impressione, come ti ho scritto anche sopra, è di una scena italiana principalmente derivativa. Sono poche le eccezioni contemporanee che seguo con entusiasmo; il resto mi annoia tremendo. Non mi interessa chi scrive per compiacere uno Specchio Mondadori o un direttore editoriale x – dimostrando così di aver appreso una lezione inesistente. Lo sappiamo dalla notte dei tempi: il problema non sono i maestri, ma gli allievi. Sorge, il problema, quando i suddetti allievi hanno pretesa di pulpito o di cattedra. Ecco: penso che la nostra letteratura contemporanea sia una letteratura di allievi; alcuni volenterosi, altri idioti. Pochi bravi. Ma sempre dipendenti. Le eccezioni esistono soprattutto nella mia generazione. Per quanto riguarda la letteratura contemporanea in generale il discorso sarebbe troppo ampio da risolvere nello spazio di una intervista. Promesso: ci scrivo un saggio senile per Gallimard.
Che devo dirti dei social? Mi divertono, niente di più. Spesso li utilizzo come laboratorio creativo; riporto storie, invento, gioco. World is my playground.
Mi fermo perché parlo troppo. Ci affidi un inedito che non ho ancora letto. Quali i prossimi progetti?
Prossimamente uscirà con Pequod il mio esordio in prosa, Sonno Giapponese. Una raccolta di racconti.




