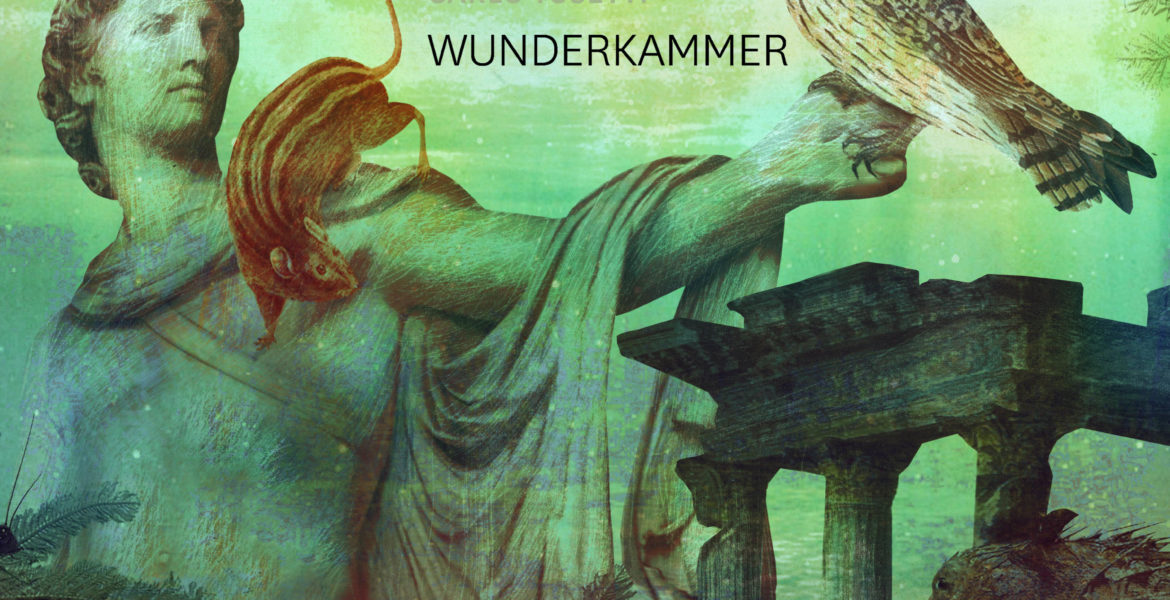Bizzarre forme ed eccentrica realtà – “Wunderkammer” di Carlo Tosetti
Andavano di moda, tra la fine del Cinquecento e il primo Seicento, le Wunderkammer o “gabinetti della curiosità”, microcosmi di esperienze messi insieme da medici, speziali, studiosi della natura, con lo scopo di soddisfare un bisogno di conoscenza sistematica. Tradurre questa esperienza in poesia è parte del lavoro svolto da Carlo Tosetti, che nella sua nuova raccolta assembla materiali eterogenei per restituirci un prodotto lirico che sia anche questo un sorta di “camera delle meraviglie”.
 Carlo Tosetti è nato a Milano nel 1969 e oggi vive a Brivio (LC). Già autore di altre raccolte liriche (Le stelle intorno ad Halley, ed. LibroItaliano, 2000; Mus Novergicus, ed. Aletti, 2004), per vivere svolge la sua attività di impiegato, trovando il tempo di occuparsi di naturopatia.
Carlo Tosetti è nato a Milano nel 1969 e oggi vive a Brivio (LC). Già autore di altre raccolte liriche (Le stelle intorno ad Halley, ed. LibroItaliano, 2000; Mus Novergicus, ed. Aletti, 2004), per vivere svolge la sua attività di impiegato, trovando il tempo di occuparsi di naturopatia.
Wunderkammer (ed. PietreVive, 2016) si configura come un prosimetro articolato in cinque sezioni, le quali sono inserite in due cornici titolate Artificialia e Naturalia. Sulla base di questi soli dati si nota subito la volontà dell’autore di incamerare nel suo spazio poetico una realtà prodotta dall’uomo ed una prodotta dalla Natura. Il risultato va oltre una mera catalogazione in versi. Infatti dello spirito catalogico di una seicentesca Wunderkammer vi è forse solo l’intento poiché, in linea con il dramma della modernità, la sistemazione del reale si configura come impossibile nella frantumazione del reale medesimo. Significativa in tal senso è l’immagine della prima lirica (difficile definirla proemiale; questa funzione è piuttosto svolta da un prosa incipitaria) dove si afferma che balugina sfatta la foglia / macerata nel guazzo (vv. 2 – 3, La Provinciale), e, lungo questo percorso di disgregazione, ritroviamo che sussistono irelitti / ben più della teredine (vv. 4 – 5, Sussistenze), ritroviamo un sole che lambisce l’oscuro / e percorre altre sue rette (vv. 10 – 12, Nord), e ancora il puzzo di storia / dei condannati (vv. 17 – 18, I Condannati).

Il rapporto dell’io con questo mondo in bilico non si configura nei termini esclusivi di una pars destruens, poiché egli decide di incrostarsi – solo – / nell’esistenza appassionata (vv. 5 – 6, Passione) rifiutando il vivere d’una passione slavata (v. 5, Passione). Quasi un atto di coraggio, forse inquadrato in termini eroici dall’uso dell’aggettivo ‘solo’. Non si sottovaluti la posizione della lirica (Passione) da cui i precedenti versi provengono: siamo all’interno della sezione Elvira e Tiresia che descrive e problematizza una visione quasi amorfa del reale, secondo la percezione dell’autore. Il metamorfismo dell’essere è il tema chiave di questa lirica, i cui protagonisti Elvira (personaggio del film Un anno con tredici lune di Rainer Werner Fassbinder, 1978) e Tiresia hanno vissuto una parte della loro vita sia come uomini che come donne. Anche il rapporto con il mito è centrale nella sezione; mito che, olio essenziale dell’uomo (così definito nella prosa Divini Paradossi), diviene un serbatoio di “vicende di mutazione” e di rilettura degli avvenimenti (per esempio in Balvano), in una compenetrazione densa tra mitologia e tema del divenire. Insiste su ciò un bagaglio lessicale funzionalizzato: Relativo è l’aspetto (v. 6, Ardore), sorse […] risorse il pitone (vv. 1 e 8, Pitone), circumnavigare / dei generi il globo (vv. 1 – 2, Elvira e Tiresia).
(personaggio del film Un anno con tredici lune di Rainer Werner Fassbinder, 1978) e Tiresia hanno vissuto una parte della loro vita sia come uomini che come donne. Anche il rapporto con il mito è centrale nella sezione; mito che, olio essenziale dell’uomo (così definito nella prosa Divini Paradossi), diviene un serbatoio di “vicende di mutazione” e di rilettura degli avvenimenti (per esempio in Balvano), in una compenetrazione densa tra mitologia e tema del divenire. Insiste su ciò un bagaglio lessicale funzionalizzato: Relativo è l’aspetto (v. 6, Ardore), sorse […] risorse il pitone (vv. 1 e 8, Pitone), circumnavigare / dei generi il globo (vv. 1 – 2, Elvira e Tiresia).
Dove si trova la Wunderkammer del titolo? In parte nella prima e nella seconda sezione (Camera delle meraviglie e dei ricordi, Elvira e Tiresia), più specificatamente nelle ultime tre (Esemplari sommersi, Esemplari ibernati, Esemplari impagliati). Accanto ai più comuni cani (in Neve ed in San Pietroburgo), ai grilli (in La festa dell’ascensione), ai passerotti (in Tre poesie sui passeri) e al sorcio (in Il sorcio), la selezione di animali sparsi nelle liriche suscita una certa curiosità nel lettore (per la loro eccentrica natura?), avvicinandosi, dunque, allo spirito di un “camera delle meraviglie”: compaiono, infatti, un regaleco (in Sussistenze), un narvalo nell’atto di inabissarsi (in Artico), un esemplare di onisco (in Nord) e curiosi anaspidei (in Glabri), in un equilibrio tra noto e poco noto, in un’oscillazione tra ricerca di originalità e dotta curiosità. Chiaro è che attraverso il mondo animale si palesa, in un gioco di specchi, la dimensione umana della vita. A tal proposito, è valorizzata, attraverso un lessico roboante per la sua natura dotta, la presenza di un immaginario animale microscopico. Se si eccettua il narvalo, siamo di fronte ad esseri che colpiscono più per la loro insignificante statura, eppure talvolta cosi armoniosi nel loro agire (Questo è tutto / degli anaspidei […] si torcon melodiosi / e si strizza lungo / solenoidi immaginari. vv. 1-2 ed 7-9 di Glabri), così affascinanti.
Parte dell’affascinazione di questa stravagante collezione di creature è dovuta certamente anche alla dimensione narrativa in cui si collocano. Lontano dal perdere la sua poeticità, il versificare di Tosetti si caratterizza anche per la sua componente narrativa rilevante in Neve e in Vuoto, con la quale riesce a produrre una cadenza affabulatoria, talvolta, però, messa in “crisi” da una sovrabbondanza di dettagli che ampliano il contenuto semantico a discapito dell’attenzione del lettore(vedi Lanterne). Ciò non toglie che una ricerca retorica, in direzione questa volta di una poeticità più “tradizionale”, compare, come in Passione, in cui incontriamo la rima interna come anche identica passione / passione (vv. 1 e 5) ed anche la figura etimologica passione / appassionata (vv. 5 e 7), con un’evidentissima insistenza semantica e tematica. Interessante è poi rilevare la presenza, accanto ad un mondo animale, di un universo vegetale vario e variopinto, inquadrabile in schemi di ascendenza ora simbolista (i castagni […] sterili, risemantizzati poiché di norma simbolo di ciclica rinascita, in La Provinciale, v. 4) ora descrittivo-naturalistica (i muschi al v. 3 di Nord).
A fronte di un percorso compatto nei suoi intenti, eterogeneo nei risultati, nasce spontaneo chiedersi come si qualifichi il lettore ideale che il poeta ha in mente. Una possibile risposta vien fuori dall’ultima lirica (non è forse l’explicit una delle sedi privilegiate dagli scrittori?) dal titolo già di per sé evocativo Il Lettore. L’atmosfera è malinconica e il lettore nei pensieri di Tosetti si staglia su di uno sfondo negativo. Sembra quasi un soggetto che ha rinunciato al suo ruolo, rinuncia metaforicamente espressa da i torcedores che […] edòtti pur nella tragedia, / […] scelsero la radio (vv. 2, 8 e 9, Il Lettore). D’altro canto, quale ruolo bisogna attendersi per il poeta? La lirica crea un denso cortocircuito. Infatti, se è vero che nel lettore protagonista possiamo vedere una metafora per designare il pubblico, è però possibile che egli rappresenti il poeta medesimo, poeta che “legge” il reale, ma che non viene ascoltato perché a lui si preferisce la radio (v, 9, Il Lettore). Rinuncia, dietro queste parole, ad un ruolo sociale della poesia?
ruolo, rinuncia metaforicamente espressa da i torcedores che […] edòtti pur nella tragedia, / […] scelsero la radio (vv. 2, 8 e 9, Il Lettore). D’altro canto, quale ruolo bisogna attendersi per il poeta? La lirica crea un denso cortocircuito. Infatti, se è vero che nel lettore protagonista possiamo vedere una metafora per designare il pubblico, è però possibile che egli rappresenti il poeta medesimo, poeta che “legge” il reale, ma che non viene ascoltato perché a lui si preferisce la radio (v, 9, Il Lettore). Rinuncia, dietro queste parole, ad un ruolo sociale della poesia?
Il fare poetico di Carlo Tosetti accarezza movenze narrative che potrebbero avvicinarlo ad un cantore del quotidiano. Ebbe a dire Montale che i poeti scrivono per altri poeti poiché sanno che spesso da chi non è del mestiere riceveranno poca attenzione. Tosetti, con il suo gusto talvolta malinconico, talvolta didascalico, non sembra abbia eccessive pretese moraleggianti o escatologiche. Non che vi sia una rinuncia totale. Piuttosto, è una poesia che si dona tra spontaneità e voglia di universalità, senza cercare lo slancio dell’enfasi. Rivela, nella sua semplicità, una quotidianità che vive di piccole creature, di miti antichi e moderni, tra cose che sono naturalia e/o artificialia, per tentare un viaggio (riuscito?) nella modernità e la ricerca di un nuovo equilibrio con la natura. La misura che più calza al ductus poetico di Carlo Tosetti è l’eccentricità, in sintonia con lo spirito di una “camera delle curiosità” (e Wunderkammer è il titolo della raccolta) che, in fondo, può dirsi immagine dell’intero mondo moderno.